- 1 . 04 - stasera I referendum in TV
- 28 . 3 - 3 . 4 - Programma del Cinema europa
- 2 . 04 - ore 20,30 - Museo Malmerendi - Alberi in città , conoscerli e prendersene cura
- 3 . 04 - ore 18 - Faventia Sales - Presentazione della ricerca- progetto MEGLIO RIUSARE CHE BUTTARE
- 4 . 04 - ore 17,30 - Lectio magistralis del Prof. Giorgio Parisi: "Energie rinnovabili per l'autonomia energetica dell'Italia, Il nucleare che c'entra?
- 4 . 04 - ore 21 - Rimini - Incontro con Luisa Morgantini - Presidente AssoPalestina
- 5 . 04 - ore 17,30 Bottega Bertaccini - Ferdinando Pelliciardi presenta il libro "Pavlon matt"
- 5 . 04 - Roma - manifestazione Movimento 5 stelle: No al riarmo dell'Unione Europea
- 8 . 04 - ore 20,30 Cinema Europa proiezione di Cortometraggi "100x100 Gaza non finirò di amarti mai"
- 11 . 04 - 18,30 - 20,30 - Assemblea/aperitivo del Circolo Legambiente Lamone
- 12 . 04 - Il 12 aprile a Ravenna «per il clima, fuori dal fossile» - di Luca Martinelli
- 12 . 04 - ore 17 - Faenza Museo del Risorgimento - Corbari - Curbéra l'umo, il partigiano, il mitora
- 3 - 5 -8 - 11- 12 - 14 . 04 - Ravenna - un mese di iniziative per USCIRE DALLA CAMERA A GAS
- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente
- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"
- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !
- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia
- Dettagli
- Scritto da ***
Nel corso del Collegio dei docenti del Liceo Torricelli Ballardini di Faenza del 21 ottobre 2024, alcune e alcuni docenti sono intervenuti in seguito alla presentazione delle nuove linee guida per l’Educazione civica, formulando rilievi, sul loro contenuto e sul metodo con cui sono state impartite. Questi e queste docenti e i/le firmatari/e di questo documento desiderano rendere pubbliche queste critiche, auspicando una discussione più ampia e riaffermando il principio della libertà di insegnamento.
Innanzitutto, in un territorio come il nostro, così profondamente colpito dagli effetti della crisi climatica, stupisce e preoccupa la scomparsa dell’espressione “cambiamento climatico”, così come l’assenza del concetto di “riscaldamento globale”. L’Agenda 2030 è stata relegata in una nota, mentre è assente il concetto di “policrisi” – economica, pandemica, ecologica, politica, migratoria – che caratterizza la nostra società e la vita di noi docenti e dei nostri studenti.
Altrettanta preoccupazione suscita la totale assenza di riferimenti alla cultura della pace, questione cruciale nei tempi di guerra che stiamo vivendo, quando dovremmo aiutare studenti e studentesse a immaginare nuove modalità per riconoscere, affrontare e superare i conflitti, senza farli degenerare in sanguinose guerre.
La lontananza di queste linee guida, del Ministero e del Ministro, dalle aule in cui insegniamo è evidente anche dalla rimozione di ogni azione educativa mirante alla riflessione sull’educazione all’affettività, alla sessualità e al contrasto della violenza di genere. Ci pare inoltre contraddittoria la lontananza dalle Raccomandazioni del Consiglio europeo del 2018, a cui si ispirano le competenze di cittadinanza delle linee guida per l'Orientamento, elaborate dallo stesso Ministero.
Le attenzioni delle linee guida per l'Educazione civica paiono, invece, prevalentemente concentrate sull’educazione alla Patria e sulla “formazione alla coscienza di una comune identità italiana”. Dal momento che, come si sa, le “identità nazionali” sono costruzioni storiche, ci pare più opportuno considerare il valore della presenza di studenti e studentesse di origine
straniera: nelle nostre classi, ogni giorno, culture diverse si incontrano e si riconoscono come tali, diverse e legittime nelle loro peculiarità e specificità, senza che nessuna debba prevalere sulle altre. Dovremmo fare in modo che questo incontro fosse pacifico e fruttuoso.
Un altro punto delle linee guide suscita perplessità: la richiesta di incoraggiare il valore dell’impresa e dell’iniziativa economica privata, che pare reinterpretare approcci etici, secondo lo spirito solidale che innerva la nostra Costituzione.
Questi sono i punti principali che noi docenti, nella discussione in collegio e fuori dal collegio, individuiamo come critici e da criticare, tutti e tutte convinti/e che qualunque contenuto debba comunque essere problematizzato e mai inculcato con formule dogmatiche, e quindi lontano da esperienze, problemi e spirazioni dei nostri studenti e studentesse.
Come docenti, siamo, inoltre, preoccupati per la continua emanazione dall'alto del Ministero, di linee guida per l'educazione civica, per l'orientamento, per i cto e per i progetti legati ai fondi Pnrr, che ostacolano lo svolgimento del nostro lavoro: instaurare un dialogo educativo sereno, proficuo e lineare, che ha bisogno di tempo, per permettere agli studenti e alle studentesse di
crescere e di formarsi come persone responsabili.
Da docenti al servizio della Repubblica, e non di un governo e di un Ministro che pare interessato a tutto tranne che ad avere cittadini critici e consapevoli, seguiremo il dettato dell’articolo 33: la nostra libertà di insegnamento sarà la libertà delle nostre classi di prendere atto delle indicazioni didattiche del Ministero ma di progettare i nostri percorsi in autonomia.
- Dettagli
- Scritto da Turi Comito su Facebook
Di questi quelli in età di voto (oltre i 18 anni) sono circa 258 milioni.
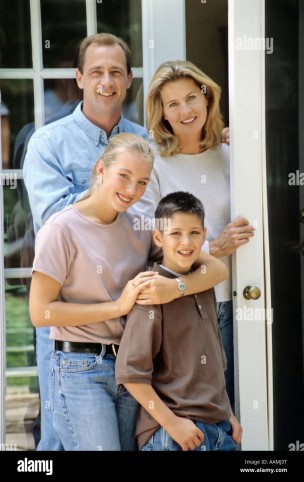
Alle elezioni presidenziali hanno votato circa 132 milioni e 400 mila cittadini. Ossia poco più del 50% degli aventi diritto.
La percentuale del 65/66 che indica l'affluenza alle urne che si legge sui giornali, si riferisce a quanti sono iscritti alle liste elettorali, non all'intera popolazione che ha teoricamente il diritto di voto (i 258 milioni). Questo perché, come noto, il sistema non funziona come in Italia/Europa dove i cittadini sono iscritti d'ufficio alle liste elettorali. Oltreoceano devi chiedere tu di potere votare.
Ora, l'iscrizione alle liste elettorali non essendo automatica risente di una moltitudine di problemi che influenzano pesantemente la rappresentanza su cui si fondano le democrazie occidentali.
Per esempio: la questione del reddito, quella dell'istruzione, quella dell'etnia di appartenenza, quella del sistema di iscrizione alle liste che ogni stato ha, eccetera.
In ogni caso parecchie ricerche mostrano come forte sia la correlazione tra medio/alta scolarizzazione o medio/alto reddito o appartenenza al gruppo etnico privilegiato (bianchi) e alta partecipazione al voto.
I bianchi, nel 2020, erano circa il 59% della popolazione e la fascia di reddito mediana (tra 30.000 e 90.000 dollari per gli individui; tra 42.000 e 127.00 dollari per una coppia e per una famiglia di quattro persone tra 67.000 a 201.000 dollari) era pari al 51% della popolazione mentre circa il 29% della popolazione vive in famiglie a basso reddito (sotto i 25.000 dollari annui) pari a circa 96 milioni di individui e, infine, quelli classificati come poveri e poveri assoluti sono (2023) l'11% della popolazione pari a circa 38 milioni di persone.
Ora, senza volere scendere nei particolari (per esempio le enormi differenze di reddito tra bianchi, neri ed ispanici) e di fronte a questi numeri non pare troppo sbagliato dire che la famosa democrazia americana si regge sulla partecipazione al voto di una minoranza classificabile, per sommi capi, come principalmente bianca e benestante (la famosa middle class) che cambia presidenti (o governatori o congressmen) a seconda dei mal di pancia che ha in un determinato momento storico.
Al momento pare che abbia, a detta di molti, prevalso in questa popolazione di elettori l'affabulazione trumpiana che si fonda su poche, ma efficaci, parole d'ordine: sigillare le frontiere alla immigrazione, riportare negli Usa la produzione industriale negli ultimi venti anni traslocata in Cina, sostenere l'industria interna con dazi fantascientifici, alleggerire le tasse, puntare sulla innovazione tecnologica e quindi, sommando tutte queste cose, aumentare i posti di lavoro e il reddito soprattutto della famosa middle class impoverita dopo la grande crisi del 2008.
Ora, in un paese in cui l'indice di Gini è tra i più elevati al mondo e in cui il 10% delle famiglie più ricche possiede il 60% della ricchezza nazionale mentre l'1% più ricco ne possiede il 27% e con quasi cento milioni di individui che campano a stento (quelli che hanno un reddito annuo da 25mila dollari in giù) ci si aspetterebbe che una delle principali azioni promesse dal candidato più votato fosse quella di una più equilibrata redistribuzione della ricchezza attraverso politiche fiscali ad hoc, in linea peraltro con le richieste di centinaia di miliardari che ogni anno scrivono lettere aperte ai governanti chiedendo di essere tassati di più (l'ultimo è questo https://www.tpi.it/economia/
Invece niente.
L'elettore trumpista non è interessato a queste cose (e, ad onor del vero manco l'elettore di Harris che ha a cuore le stesse cose cha ha a cuore l'elettore trumpista solo che invece che sbavare mentre mangia nel fast food si pulisce la boccuccia con il tovagliolino che tiene sulle gambe al ristorante).
L'elettore trumpista, piccolo borghese impoverito o arricchito che sia, non è interessato a un riequilibrio della ricchezza. Non è interessato a cercare di capire che significa aumentare i dazi a dismisura (per esempio significa che la stessa merce cinese o italiana che compravi prima a 10$ adesso la comprerai, americana, a 15 o 20. Se potrai permettertela). Non è interessato a chiedersi che faranno gli altri paesi di fronte a scelte come queste e se esistono seri rischi di conflitto economico (e non solo) dalle conseguenze pochissimo allegre. Non è interessato a capire perché alle porte delle sue frontiere bussano milioni di morti di fame invece che starsene nei loro paesi. Non è interessato a capire come sia stato possibile che in 40 anni (da Reagan in poi) la sua famosa classe sociale di appartenenza si sia impoverita drasticamente mentre i nuovi ricchi si sono arricchiti fuori da ogni fantasia e logica.
L'elettore trumpista (e quello harrisista) ha una dimensione dei fenomeni sociali e politici (nazionali e globali) che coincide coi suoi problemi personali/familiari.
Per cui il problema è, per quello impoverito, di tornare ad avere la villetta col giardino e il SUV posteggiato davanti casa e, per quello ancora benestante, di non perdere quello status.
Perché questa è l'essenza, lo spirito guida, la ragion d'essere, del piccolo borghese americano e non solo: il suo scandaloso individualismo e il suo perverso "patriottismo", questo suo perverso amore per una "patria", un paese, che manco conosce poiché la sua vastità è gigantesca e le differenze abnormi.
Trastullarsi dietro l'idea - molto in voga tra gente di destra e di sinistra dalle nostre parti - che il trumpismo sappia parlare alle fasce più deboli di una società a me sembra se non idiozia superficialità.
Trump (o Harris) non parla alle decine di milioni di diseredati che crepano perché non hanno da mangiare o da curarsi o a quelli che sbarcano il lunario arrangiandosi in tutti i modi, legali e illegali, possibili.
Parla a quelli che hanno paura di perdere il loro status di piccoli ridicoli privilegiati o a quelli che lo hanno perso e vogliono a tutti i costi recuperarlo.
Parla, cioè, al piccolo borghese maggioritariamente presente nel paese. Quello che va ad iscriversi alle liste elettorali. Che ha il tempo e l'occasione per farlo (a proposito: nelle zone più depresse, quelle a più alta densità di marginalità, non vengono manco messi su i seggi elettorali).
Viene da chiedersi perché il "gigante dormiente", cioè proprio quella popolazione di marginali o quasi (quantificata prima in circa 100milioni di individui) non vada a votare o non cerchi una alternativa partitica (e dire che esiste il partito socialista, quello comunista, quello laburista e molti altri partiti "radicali" esistono anche lì) o perfino non metta mano alla pistola e faccia una rivoluzione.
La risposta, che io ritengo l'unica degna di essere presa in considerazione, è quella che diede parecchi decenni fa Steinbeck: "Il fatto", disse, "è che i poveri non vedono loro stessi come membri oppressi del proletariato, bensì come milionari temporaneamente in difficoltà".
Il famoso "sogno americano" sta tutto in quelle parole: la speranza, per molti, (e forse anche la rassegnazione), prevale su qualunque idea di lotta sociale e collettiva.
E questa idea, fondata sulla cosiddetta meritocrazia, sul sacrificio personale, sullo scalare vette per arrivare in cima (anche se sei un Sisifo qualunque destinato al più totale dei fallimenti), sull'idea che la tua genialità e il tuo sapere approfittare delle opportunità alla fine premi, sull'idea che tutto dipende da te e pochissimo dal mondo che ti circonda e che solo i parassiti chiedono aiuto, non solo è radicata morbosamente al di là dell'oceano ma ha preso piede pure in Europa ormai da più di un trentennio.
Il piccolo borghesismo gretto e individualista, "narrow minded" come dicono da quelle parti, a dispetto delle lauree prese e dei dollari/euro in banca posseduti, è il nuovo fantasma che si aggira per il mondo.
Un fantasma che sta impossessandosi di tutti.
Se già non l'ha fatto.
- Dettagli
- Scritto da Andrea Fabozzi su il manifesto
Potere assoluto Trump e la cerchia di miliardari che ha deciso di investire su di lui, esponenti della classe che ha la maggiore (se non la piena) responsabilità dei disastri nei quali siamo immersi - dalla crisi economica a quella climatica alle guerre - riescono a presentarsi come la via di uscita dal pantano
«You’re the media now», difficile trovare un commento più rivelatore della vittoria di Donald Trump. Lo ha scritto Elon Musk, il prescelto, il «super genius», ma anche il proprietario di X, la piattaforma ex twitter dove ha immediatamente postato il suo commento. Ma dove «il media» non è certo l’utente comune al quale si rivolgeva. Perché in effetti il media è proprio lui, Musk.
Lo è fino in fondo, visto che smaccatamente dichiara di fare della sua piattaforma un uso politico in favore dell’agenda trumpiana, palesi o nascoste dietro gli algoritmi che siano le sue mosse. Dunque un padrone che dice al popolo: il padrone sei tu. Riuscendo a essere convincente, così come convincente, e vincente, è stato Trump nel proporsi come un paladino della classe media.
Il racconto che contraddice la realtà è un elemento centrale di questo successo. Trump e la cerchia di miliardari che ha deciso di investire su di lui, esponenti della classe che ha la maggiore (se non la piena) responsabilità dei disastri nei quali siamo immersi – dalla crisi economica a quella climatica alle guerre – riescono a presentarsi come la via di uscita dal pantano. Ci riescono non in nome di un programma politico – che pure hanno, nero su bianco, e che fa terrore – ma in virtù di un discorso emozionale che trasforma ogni elezione, anche quelle per la presidenza, in un referendum sulle piccole rassicurazioni alle quali nessuno vuole rinunciare. I confini protetti, i valori tradizionali, il maschilismo tra questi, la sicurezza nel vicinato.
La redazione consiglia:
Il potere logora chi ce l’aveva, è ora di nuovi leaderNella costruzione del racconto alternativo a quello fattuale è fondamentale il ruolo delle piattaforme proprietarie digitali. Non solo simbolicamente siamo più vicini che mai all’insediamento del più ricco tra i tech-bilionaries direttamente alla Casa bianca. Il capitalismo della sorveglianza prima che un progetto politico è stato un perfetto modello di business, talmente perfetto da poter reagire alle avvisaglie di crisi prendendo direttamente il potere. Con un’agenda niente affatto nascosta che devasterà ulteriormente il mondo, arricchirà i ricchi e impoverirà diversi milioni di elettori di Trump.
In una partita in cui la comunicazione finisce con l’essere tutto – terreno, strategia e misura stessa del gioco – i mezzi di comunicazione tradizionali fanno la fine del partito democratico, non toccano palla. Dietro alle scrivanie dove ancora valgono la razionalità del discorso neoliberale e le forme della democrazia, Trump evidentemente è un corpo estraneo. Infatti parla altrove, lui e i suoi paladini, la infosfera non è avara di spazi. Se una novità segnala questa campagna è forse il declino di un mezzo antico che aveva fin qui mantenuto la sua centralità nell’informazione, la televisione. Trump ha straperso l’unico dibattito televisivo fatto con Harris e si è rifiutato di farne altri, ma la debacle non ha pesato. Anzi, anche in quel frangente, più si è spinto su posizioni estreme – «gli haitiani mangiano i cani» – diventando un meme, più ha consolidato il suo elettorato (persino nella contea dei falsi mangiacani) senza perdere voti.
Dopo le prove generali quattro anni fa, queste sono state le prime elezioni giocate dall’inizio alla fine senza alcuna base fattuale condivisa dalle due parti in contesa. In gran parte schierati contro Trump, i media tradizionali con il New York Times in testa non hanno però proposto su nessuno dei temi centrali nel racconto del tycoon – sicurezza, immigrazione, protezionismo economico – un punto di vista alternativo, ma solo più moderato. Un po’ come il partito democratico. Lo stesso episodio degli abbonati in fuga dal Washington Post per il mancato endorsement ad Harris, letto dai liberal come una testimonianza di vitalità del pensiero critico, è da valutare con più attenzione.
Il giornale in fondo non ha mutato, fino a ieri, la sua linea critica verso Trump, ma per ragioni di evidente opportunismo del suo proprietario Bezos si è astenuto dall’ufficializzarsi «pro dem». Tanto ha scatenato la crisi, perché questo sono diventati anche i media mainstream: un recinto per tifoserie. Destinati, però, adesso, a non godere neanche dell’effetto panico da prima volta, quel Trump bump che gonfiò le vendite otto anni fa. L’informazione di qualità per élite resiste al riparo dietro costosi paywall, ma questi funzionano anche come schermo verso la realtà degli elettori. Non capito e non previsto, è arrivato il diluvio
Commenta (0 Commenti)- Dettagli
- Scritto da Luca Celada LOS ANGELES su il manifesto
Il male minore Alla ferocia annunciata di Trump, i democratici non hanno trovato di meglio che riprendersi la bandiera e le uniformi e ignorare il movimento per la pace

Femmina. Il paradosso delle elezioni Usa 2024 è quanto centrale sia stata la questione gender e al contempo quanto defilato sia stato il sesso della seconda candidata donna della storia.
Il gender divide ha sotteso tutta la stagione da quando il passo indietro di Joe Biden ha preso in contropiede Donald Trump spingendolo ad enfatizzare ancor più gli aspetti machisti di una campagna saldamente ancorata nella manosphere, dai miliziani maschi della alt right ai tech bros della Silicon Valley.
La campagna è finita con Julia Roberts che suggeriva alle donne di votare in coscienza, senza dirlo ai mariti. «Il seggio – recita l’attrice nello spot – è l’ultimo posto dove le donne hanno ancora libertà di scelta» (ogni riferimento all’espressione usata nel contesto dell’aborto è tutt’altro che casuale).
«Il seggio è l’ultimo posto dove le donne hanno ancora libertà di scelta»Julia Roberts prima del voto
Intanto, nei comizi di chiusura, Trump citava l’urlo di Peter Finch nel Quinto Potere di Sidney Lumet: «We’re not gonna take it anymore!».
«Non lo accetteremo più!», citazione scelta da Trump per estrarre le ultime gocce di gutturale e amorfa ribellione da una base usata per spianare la strada del potere ad una plutocrazia senza scrupoli.
L’immaginario filmico misura il terreno emozionale dello psicodramma che nella nostra notte gli americani hanno tentato di elaborare nelle urne.
IL TERZO ASSALTO trumpista alla democrazia riassume elementi delle crisi di molte democrazie occidentali spaccate fra establishment liberal-liberisti e sfide nazional populiste da destra.
Nell’eccentrico sistema elettorale Usa, disuguaglianze e deficit di riconoscimento sono ingrandite dalla tara che ingigantisce l’influenza di piccoli stati deindustrializzati. E in questo senso il fenomeno trumpista prende impeto sfruttando distorsioni quantificabili.
Ma la patologia demagogica in cui è stata risucchiata la politica americana è indice di uno squilibrio più profondo.
Altrimenti le istanze sacrosante contro le aberrazioni tardo capitaliste non troverebbero sbocco nella distopica coalizione di nativismo rancoroso con una plutocrazia utopista e psicotica come quella rappresentata da Elon Musk e Robert Kennedy Jr., e il progetto di «decostruzione dello stato amministrativo» così funzionale ai nuovi monopoli.
In questo senso, nell’implosione di una realtà condivisa in grado di sostenere un dialogo politico, l’America ha già perso. Quelle dello schieramento Kamala Harris, (simile a quelli di unità nazionale, visti in Francia e altrove) sono battaglie di retroguardia, in gran parte combattute per salvare il salvabile di un welfare state sempre più precario.
Ma la ritirata è già avvenuta. Su protezionismo e immigrazione, ad esempio, dove le istanze della destra sono state in gran parte cooptate nell’illusione di arginare l’emorragia di elettori. E la mentalità del riarmo che coincide con la proporzionale erosione di diritti e diplomazie e l’acquiescenza agli orrori dilaganti della guerra.
Nel caso Usa la responsabilità è diretta e proporzionale all’egemonismo proiettato nelle 750 basi militari nel mondo.
DI CONTRO vi era l’abiezione morale di un aspirante autocrate che alcuni vorrebbero interpretare in chiave positiva di un immaginato «pacifismo trumpista», come se l’opportunistico isolazionismo potesse distrarre gli Stati uniti dall’egemonismo, invece di collocarli in perfetta sintonia con quelli di Putin, Netanyahu, Bin Salman, Milei e la marea montante degli illiberismi nativisti e fanatici.
In questa disfida dei mali minori è proprio l’egemonismo a essere in gran parte ignorato da un elettorato beato nella incoscienza del proprio peso sul pianeta.
Come ha segnalato la scorsa settimana su Zeteo, l’autore di origini vietnamite, Viet Thahn Nguyen, anche fra molti progressisti, la postura globale rimane inquadrata nei semplicismi di una mitologia imperniata sulla predestinazione americana ad esportare libertà.
Quello di Thahn è stato fra i rari interventi capaci di contemplare l’insofferenza di chi nel mondo stenta ad empatizzare con lo psicodramma di molti liberal americani. Per molti progressisti, scrive Tahn, l’orrore trumpista deriverebbe dal dover subire su suolo nazionale l’ira funesta negli anni inflitta, e disinvoltamente rimossa, a così tanti popoli.
Eppure alla ferocia annunciata di Trump, i democratici non hanno trovato di meglio che riprendersi la bandiera e le uniformi per «non concedere al Grand old party l’esclusiva sul patriottismo». E di ignorare il movimento per la pace.
Per questo sappiamo, tutti noi che i genocidi oggi li seguiamo in diretta social con sempre meno risposte, che il prossimo presidente americano, uomo o donna che sia, sarà difficilmente in grado di proporne
Commenta (0 Commenti)
- Dettagli
- Scritto da Amedeo Ciaccheri su il manifesto
Opinioni Dopo il voto ligure vanno messi a valore i semi di speranza del territorio: reti sociali, amministratori locali, laboratori di autogoverno impegnati a contendere spazi alla destra. C’è un mondo che si riconosce in un nuovo civismo e aspetta che venga organizzato e accolto, e non nascosto, come accade così spesso nelle segreterie nazionali
All’indomani del voto ligure, l’editoriale del direttore del manifesto ha messo in fila una dopo l’altra le ragioni di un campo che non tiene il passo della sfida. Non servono mezzi termini, e già solo l’incipit, «per non continuare a perdere», suona come una scudisciata che dovrebbe far riflettere un bel pezzo della classe dirigente della sinistra del nostro paese, dovunque sia collocata.
Partiamo da noi. Partiamo da quella parte della coalizione che crede che nel paese serva radicalismo sociale e capacità di dare risposte ai territori. Alleanza Verdi e Sinistra può diventare parte della soluzione, a meno di voler trasformare un allarme in una solida delusione. Eppure sarebbe cosi semplice ripartire.
Le ultime elezioni europee hanno nascosto tra i numeri dei risultati un pericolo terribile che si manifesta oggi violento, ma che riposa da tempo in uno spirito tragico incarnato dalla sinistra. Resistere per esistere. E per farlo abbiamo scambiato le parti con il centrodestra berlusconiano, in una ripetizione grottesca. Leaderismo, opinion maker, foto opportunity, un intero prontuario di una cassetto degli attrezzi politici, che per quanto sia ormai radicato nel nostro tempo, non può bastare per chi continua a credere che le condizioni materiali dell’ultimo dei nostri concittadini siano il terreno di battaglia, che si tratti di diritti civili, di qualità della vita, di emancipazione e dignità. Sopratutto non bastano per vincere. Vent’anni fa il centrosinistra chiamava alla riscossa contro il berlusconismo inventando il protagonismo dei sindaci e delle coalizioni territoriali. Ci siamo ritrovati con lo smacco di aver regalato al centro destra una chiave per consolidare un consenso ancora maggioritario nel paese. Il Sindaco di tutti i sindaci, così ha festeggiato Marco Bucci appena eletto governatore. Uno smacco dal sapore amaro.
In Liguria non solo il campo non si allarga, ma il voto delle europee e delle politiche messo in congelatore là è rimasto. Mentre tutto corre, tutto ciò che non possiamo permettere alla sinistra è rimanere ferma, e non mettere a valore i semi di speranza che territorio per territorio crescono in mezzo alla tempesta. Reti sociali, amministratori locali, piccoli o grandi laboratori di autogoverno che contendono il campo alla destra corpo a corpo, in un picchetto antisfratto o nell’amministrazione di una città, di un comune, di una periferia maltrattata.
Il grande compito che avrebbe Alleanza Verdi e Sinistra, grande perché semplice. Battere un colpo. Uscire dal voto per risarcimento agli sconfitti, e conquistare il consenso che nasce da chi vuole ancora lottare. In Umbria e in Emilia Romagna è oggi la trincea, ma in trincea da sempre non vince nessuno, si può spostare la linea della sfida un poco più avanti ma cosi non basterà mai.
Serve la politica dice giustamente il direttore del manifesto. E la politica ha bisogno di spinte, ha bisogno di fame di vittoria, di ambizione e di popolo, come in un film grande che sta risvegliando sentimenti sopiti. Serve praticare e non assorbire, serve guardare a chi ancora nutre la speranza come azione, alle migliaia di volontari che in Emilia Romagna come in Spagna, a Bologna come a Valencia, sono scesi in strada, vanghe alla mano, per salvare almeno una vita, liberare una casa, salvare un’impresa, ma non solo, per mettere i corpi di fronte alla politica e a chi nega il cambiamento climatico, rispondere in cammino per chiedere di cambiare tutto. La solidarietà è la tenerezza dei popoli, diceva Che Guevara, e la tenerezza è un sentimento rivoluzionario.
Resistere per cambiare, per vincere, non per esistere, una lezione importante che dovremmo imparare dalla France Insoumise dopo aver festeggiato anche in Italia per un successo insperato.
Ecco senza una spinta ad accogliere tutto questo, in Europa come in Italia, in Liguria, come a Roma, la partita è già scritta, perché il gorgo che ci circonda è più profondo di un sondaggio. C’è un mondo che si riconosce in un nuovo civismo e aspetta che venga organizzato e accolto, e non nascosto, come accade così spesso nelle segreterie nazionali di chi oggi ha il compito di organizzare l’alternativa. Lo chiamavamo Municipalismo, possiamo tornare a dargli spazio e voce, basta poco. E che non trovi spazio dignitoso ancora in un progetto nazionale è una domanda a cui urgentemente servirà rispondere.
«Facite a faccia feroce», pare ordinassero gli ufficiali borbonici alle truppe stremate che poi sarebbero state sconfitte. Ecco non basta mettere su la faccia più convincente che abbiamo per cambiare la storia, dobbiamo fare qualcosa di più
Commenta (0 Commenti)
- Dettagli
- Scritto da Riccardo Liguori su GreenMe
L'alluvione che ha colpito la Spagna ha scatenato teorie infondate sul cloud seeding. Antonello Pasini, fisico del clima e primo ricercatore del Cnr, ci spiega cos'è il cloud seeding e perché non può aver causato un evento di tale portata
L’alluvione che ha colpito la Spagna, causando quasi 220 vittime e 2000 dispersi, ha riacceso i riflettori sul cambiamento climatico e sui suoi effetti sempre più estremi. Tra le preoccupazioni legittime, si sono insinuate però anche teorie del complotto che cercano di attribuire la tempesta ad attività di “cloud seeding“ (inseminazione delle nubi) condotte in Marocco lo scorso agosto.
Per fare chiarezza, abbiamo interpellato Antonello Pasini, fisico del clima e primo ricercatore al Cnr, che ci ha spiegato perché queste teorie non hanno alcun fondamento scientifico. “L’inseminazione delle nubi è una tecnica sperimentale per far piovere, utilizzata da decenni, ma che non ha mai portato a risultati sicuri“, afferma Pasini. “Di sicuro, la tecnica utilizzata in Marocco in agosto non può causare quello che è successo in Spagna. È una tecnica che può incrementare le precipitazioni del 10, 15 o al massimo 20%, ma non originare un’alluvione così importante, tra l’altro a molta distanza da dove è stato fatto eventualmente il cloud seeding”.
Ma cos’è esattamente il cloud seeding?
Si tratta di una tecnica di modificazione delle nubi che mira ad aumentare le precipitazioni. In pratica, si sparano nelle nuvole, tramite aerei o cannoni, particelle di ioduro d’argento che favoriscono la condensazione del vapore acqueo e la formazione di gocce di pioggia.
Questa tecnica viene utilizzata soprattutto in Paesi con climi aridi, come gli Emirati Arabi Uniti, per cercare di mitigare gli effetti della siccità. Ma come sottolinea Pasini, “fa piovere un po’ di più sul territorio dove la si sperimenta e a valle di quel territorio, semmai, piove di meno. Quindi ci sono eventualmente problemi transfrontalieri per questo fatto, come capita in Medio Oriente dove il Paese che utilizza questa tecnica ne beneficia mentre i Paesi limitrofi si trovano costretti a sperimentare siccità“.
Perché il cloud seeding in Marocco non può aver causato l’alluvione in Spagna?
Ci sono diverse ragioni per cui questa ipotesi è infondata. Innanzitutto, come spiega Pasini, il cloud seeding ha un effetto locale e limitato nel tempo. “Non puoi farlo in Marocco e avere effetti in un altro Paese”, afferma il fisico. “Inoltre, gli effetti di questa tecnica si limitano a qualche decina di minuti dopo le operazioni, al massimo qualche ora: è dunque da escludere che operazioni effettuate giorni o settimane prima abbiano potuto influire anche solo minimamente su quanto è accaduto in Spagna“.
In secondo luogo, l’efficacia del cloud seeding è molto limitata, anche nei casi in cui funziona meglio. “Può aumentare le precipitazioni del 10% circa”, spiega Pasini. “Non conosciamo nel dettaglio i risultati degli esperimenti svolti in Marocco, ma anche supponendo un aumento del 10% delle precipitazioni, l’evento di Valencia sarebbe comunque stato catastrofico, vista la quantità di pioggia caduta”.
Infine, è importante ricordare che con il cloud seeding non si può far piovere a comando. “Al massimo si possono aumentare le precipitazioni che già ci sarebbero state per cause naturali”, precisa Pasini.
La vera causa dell’alluvione: la crisi climatica
Le alluvioni che hanno colpito la Spagna sono state causate da una combinazione di fattori meteorologici, tra cui una “goccia fredda” che ha prodotto violenti temporali autorigeneranti. Ma l’intensificatore di fondo è il cambiamento climatico, che sta aumentando la frequenza e l’intensità di questi eventi estremi.
Come ha sottolineato la World Meteorological Organization, “le precipitazioni sono state più abbondanti del 12% circa e 2 volte più probabili rispetto al clima in epoca preindustriale”.
È quindi fondamentale affrontare la crisi climatica con urgenza, riducendo le emissioni di gas serra e investendo in misure di adattamento per proteggere le comunità dagli impatti sempre più devastanti del cambiamento climatico. Diffondere teorie del complotto non solo è inutile, ma distoglie l’attenzione dal vero problema e, soprattutto, ritarda le azioni necessarie per affrontarlo.
Commenta (0 Commenti)
- Striscia di sangue infinita, la strage dei bambini senza volto - di Eliana Riva
- Tossine letali e lacrime di coccodrillo - di Micaela Bongi
- «Prima noi», Trump dichiara la guerra mondiale dei dazi - di Marina Catucci
- Difesa europea, Europarlamento approva Relazione: Pd dice sì, M5S attacca adn Kronos
- Il protezionismo che accelera la crisi dell’impero americano - di Emiliano Brancaccio
- 5 aprile, Avs aderisce Conte chiama Schlein «Confido che ci sia» - di Giuliano Santoro
- «Pronti a rispondere» ma l’Unione europea già si guarda in tasca - di Andrea Valdambrini STRASBURGO
- Netanyhau a Budapest, la chiamata è per l’Europa- di Luca Baccelli
- Schlein chiude a Calenda: «Noi al governo solo col voto» - di Andrea Carugati
- «ll no al riarmo oltre i confini di parte, la piazza del 5 aprile è aperta» - di Giuliano Santoro
- Orbán calpesta l’Aja: Netanyahu ospite d’onore a Budapest - di Lorenzo Berardi
- Lunedì Rosso del 31 marzo 2025
- Economia - Meloni ha un problema: si chiama von der Leyen - di Roberto Ciccarelli
- Al cuore del progetto autoritario - di Francesco Strazzari
- Landini: «Per fermare la guerra servono diritti e democrazia» - di Giuliano Santoro





