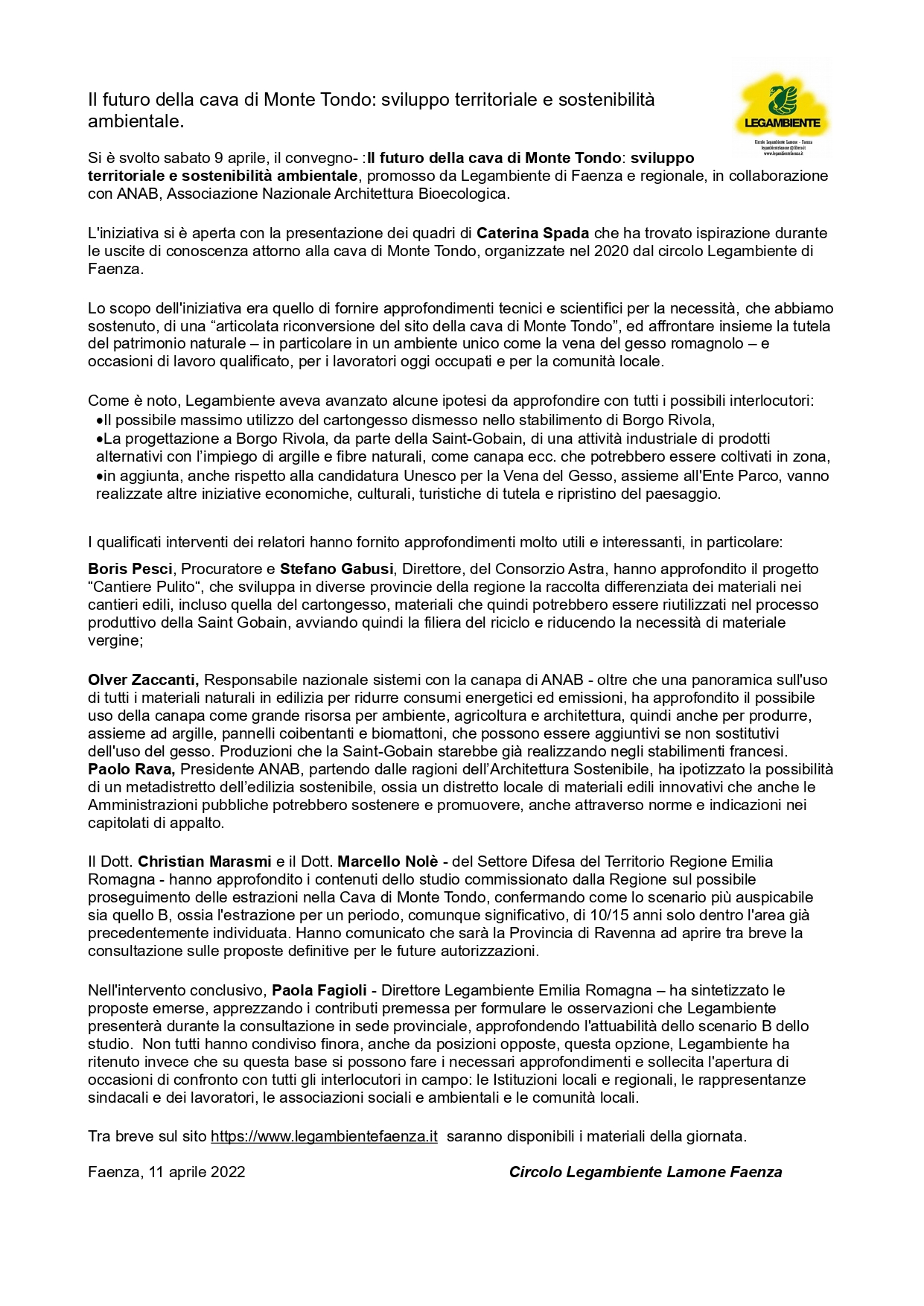- 1 . 04 - stasera I referendum in TV
- 28 . 3 - 3 . 4 - Programma del Cinema europa
- 2 . 04 - ore 20,30 - Museo Malmerendi - Alberi in città , conoscerli e prendersene cura
- 3 . 04 - ore 18 - Faventia Sales - Presentazione della ricerca- progetto MEGLIO RIUSARE CHE BUTTARE
- 4 . 04 - ore 17,30 - Lectio magistralis del Prof. Giorgio Parisi: "Energie rinnovabili per l'autonomia energetica dell'Italia, Il nucleare che c'entra?
- 4 . 04 - ore 21 - Rimini - Incontro con Luisa Morgantini - Presidente AssoPalestina
- 5 . 04 - ore 17,30 Bottega Bertaccini - Ferdinando Pelliciardi presenta il libro "Pavlon matt"
- 5 . 04 - Roma - manifestazione Movimento 5 stelle: No al riarmo dell'Unione Europea
- 8 . 04 - ore 20,30 Cinema Europa proiezione di Cortometraggi "100x100 Gaza non finirò di amarti mai"
- 11 . 04 - 18,30 - 20,30 - Assemblea/aperitivo del Circolo Legambiente Lamone
- 12 . 04 - Il 12 aprile a Ravenna «per il clima, fuori dal fossile» - di Luca Martinelli
- 12 . 04 - ore 17 - Faenza Museo del Risorgimento - Corbari - Curbéra l'umo, il partigiano, il mitora
- 3 - 5 -8 - 11- 12 - 14 . 04 - Ravenna - un mese di iniziative per USCIRE DALLA CAMERA A GAS
- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente
- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"
- Diritto di voto elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie 8 e 9 giugno 2025, Scarica la domanda editabile di ammissione al voto
- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !
- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia
- Dettagli
- Scritto da Giuovanni Dosi e Andrea Roventini su Collettiva
La decisione del Parlamento è sbagliata da ogni punto di vista. C'è un problema etico: si rafforza la corsa al riarmo. Ma c'è anche un nodo strategico: è possibile modernizzare la difesa senza colpire le spese sociali più urgenti, in un quadro di cooperazione europea
Sull’onda della guerra in Ucraina, il governo italiano con l’appoggio del Parlamento ha deciso di aumentare le spese militari dell’Italia al 2% del Pil, in linea con vecchi accordi (peraltro mai ottemperati) presi con la Nato. Si tratta di un incremento complessivo di circa 13 miliardi di euro, pari allo 0,59% del Pil. Inizialmente la crescita delle spese militari doveva avvenire entro il 2024, ma l’opposizione del Movimento Cinque Stelle ha fatto slittare la scadenza al 2028.
Questa scelta politica porta a una serie di riflessioni. La prima, e maggiore, è di natura etico-politica. Deliberare un aumento delle spese durante una guerra tra Ucraina e Russia è, come ha sottolineato tragicamente Papa Francesco, semplicemente folle. Rappresenta un allineamento supino a un progetto di riarmo di lungo periodo, presentato come garanzia di pace anziché una escalation di una possibile nuova guerra fredda.
In secondo luogo, anche dal punto di vista meramente politico-pragmatico, essa rappresenta un superamento dei vincoli sul bilancio pubblico che hanno gravato sull’Italia dall’entrata in vigore del trattato di Maastricht, ma nella direzione sbagliata. L’allentamento della disciplina fiscale che grava sui Paesi dell’Unione monetaria europea è certamente una buona notizia, dati gli effetti disastrosi delle regole di bilancio comunitarie. Tuttavia, se l’aumento tempestivo del deficit pubblico era una scelta obbligata di fronte alla crisi sociale ed economica scatenata dal Covid, l’accelerazione della crescita delle spese militari è una scelta politica di fare una specifica eccezione alla generale “filosofia dell’austerità“.
Come noto, la narrazione degli ultimi decenni volta al contenimento della spesa pubblica italiana ha portato a tagli della spesa in sanità, istruzione, welfare e ricerca e degli investimenti pubblici. Il quadro è ancora più drammatico se si considera la dura lezione di austerità fiscale che è stata impartita alla Grecia durante la crisi del 2011, con il conseguente crollo dell’economia, l’aumento vertiginoso della disoccupazione e a una vera e propria tragedia sanitaria, senza neppure stabilizzare il debito pubblico.
È stupefacente come nel dibattito di questi giorni sull’aumento delle spese militari italiane si sia sorvolato leggiadramente sul loro impatto negativo sul deficit pubblico anche da parte dei “rigoristi”, in un quadro macroeconomico fortemente negativo per gli strascichi della pandemia e il forte aumento del prezzo dell’energia e delle materie prime (la spesa militare ellenica è cresciuta fino al 2,79% del Pil nel 2020). Parafrasando Orwell: è come se tutte le spese pubbliche fossero uguali, ma quella militare è molto più uguale delle altre.
La terza considerazione riguarda l’oggetto stesso dell’aumento delle spese militari. Allo stato attuale, molti membri della Ue stanno aumentando le loro spese senza un progetto concreto di difesa né europea né nazionale. In ultima istanza, gli europei stanno procedendo a un enorme sussidio all’industria militare americana, all’interno degli obiettivi geopolitici americani, come peraltro avviene anche per i nuovi acquisti di gas di scisto liquefatto. Dovrebbe essere ovvio che una qualsiasi strategia di armamento debba essere definita dagli obiettivi strategico-militari propri, europei e/o nazionali.
Nelle more di una politica europea, che può venire solo insieme a una politica estera europea (ricordiamoci per esempio che in Libia italiani e francesi sono su fronti opposti), le scelte debbono riguardare la proiezione strategica nazionale da un lato, le ricadute industriali nazionali ed europee dall’altro. I vertici delle nostre forze armate hanno spiegato ripetutamente quelli che dovrebbero essere i nostri obiettivi, specialmente nel Mediterraneo. Non ci risulta che abbiano menzionato l’obiettivo e nemmeno la possibilità di uno scontro militare con la Russia.
Se però questo obiettivo viene esplicitamente escluso, allora si può, e probabilmente si deve ammodernare il nostro apparato militare senza alcun aumento aggiuntivo del rapporto spese/Pil e con molto maggiori ricadute tecnologiche sull’industria italiana ed europea. Una prima ovvia urgenza, indipendente da ogni obiettivo strategico: occorre svecchiare massicciamente le forze armate, pre-pensionando, ovviamente in maniera non punitiva, parecchie migliaia di sottufficiali, ufficiali e soldati.
Secondo punto, e qui sta la decisione più delicata: è opportuno interrompere subito il programma di acquisti di F-35. Abbiamo ottimi caccia europei, gli Eurofighter Typhoon, e ancora efficientissimi bombardieri Tornado. L’acquisto degli F35 non è solo costosissimo, ma porta benefici tecnologici e produttivi limitati all’industria italiana (ed europea). La sua chiusura libererebbe ingenti risorse che potremmo dedicare, tra l’altro, allo sviluppo del velivolo di nuova generazione europeo Tempest, una joint venture anglo-italo-svedese.
Possiamo continuare: è una necessità avere droni europei anziché dipendere dai Predator americani, cosi come se vogliamo missili è assurdo comprare un concorrente americano di qualità forse inferiore invece di sviluppare quelli Mbda, nei quali l’italiana Oto Melara ha un ruolo consistente. E l'elenco sarebbe ancora lungo.
Il punto chiave è che ognuna di queste scelte di affrancamento militare dai prodotti “made in Usa”, svilupperebbe ulteriormente l’industria italiana della difesa e sarebbe il primo passo per la creazione di nuovi progetti di cooperazione industriale europei, che nel caso di Airbus, hanno funzionato molto bene. Inoltre ci sarebbero delle ricadute economiche positive: in Usa: il finanziamento della ricerca e sviluppo connessa alla difesa e le commesse del settore militare hanno avuto un ruolo chiave nello sviluppo tecnologici e nella creazione di nuove imprese e industrie. Non ha senso che l’Italia e l’Unione Europea si privino di questo strumento a favore dell’economia americana.
Il punto fondamentale è che se vogliamo ammodernarci militarmente possiamo farlo, senza ledere altre spese sociali enormemente più urgenti e favorendo l’economia nazionale. Basta deciderlo. E chi lo può decidere siamo solo noi, in un quadro di cooperazione europea.
- Dettagli
- Scritto da Stefano Iucci su Collettiva
Si programmano investimenti di guerra per 15 miliardi di euro in più fino al 2026: esattamente i 7,5 miliardi di euro in meno destinati in un quadriennio all'istruzione. Sinopoli, Flc Cgil: ci batteremo contro l'aumento delle spese militari
Non c'è nessun dubbio. È scritto nero su bianco nel Def: la spesa per l'istruzione negli anni 2022-2025 scende dal 4 al 3,5% del Pil. Un dato che risulta ancora più grave, se confrontato col fatto che, contemporaneamente, si programmano investimenti di guerra per 15 miliardi di euro in più fino al 2026. E i conti sono presto fatti: sono esattamente i 7,5 miliardi di euro in meno destinati in un quadriennio all'istruzione.
"In questo modo ci allontaniamo ancora di più dalla media Ocse – attacca il segretario generale Flc Cgil Francesco Sinopoli –. Dopo due anni di pandemia, quando è diventato chiaro a tutti quanto sia fondamentale per il Paese il nostro sistema d'istruzione, dopo tanta retorica e pochissime risorse per affrontare l'emergenza, si torna esattamente alla stessa logica ragionieristica dei tagli degli ultimi venti anni".
Come nulla fosse, siamo di nuovo a una politica che ha i suoi precedenti nefasti nel 2008 quando si mandarono a casa ben 130.000 lavoratori, un taglio alle risorse da cui la scuola pubblica si deve ancora risollevare e che gli investimenti del Pnrr non riescono a risarcire.
Non va meglio neanche per gli stipendi, visto che, sottolineano alla Flc, "se ne programma la riduzione fino al 2025 per una somma equivalente a più di un punto di Pil. Una vera e propria beffa per una categoria di lavoratrici e lavoratori che già soffre di una disparità rilevante rispetto ai colleghi europei e agli altri lavoratori pubblici a parità di titolo di studio e che fatica, con salari già depressi, a recuperare potere d'acquisto di fronte di all'inflazione sempre più elevata".
"Lo abbiamo detto e lo ribadiamo oggi, ci batteremo contro l'aumento delle spese militari per affermare quelle che sono le vere priorità del Paese in primo luogo l'istruzione e la ricerca", commenta Sinopoli.
Sul tema della spesa per il riarmo è sulla stessa lunghezza d'onda Maurizio Landini, segretario generale Cgil: "Penso che abbia ragione il Papa quando dice che è sbagliato investire sul riarmo ora nel mondo. Sembrerà utopistico mentre è in corso una guerra, ma c’è davvero bisogno di affermare la cultura del multilateralismo con al centro l’uomo. Ha ragione il Papa a chiedere d'immaginare un altro mondo”.
Cultura e multilateralismo: impossibile ripartire da qui, senza investire seriamente in istruzione e ricerca.
- Dettagli
- Scritto da Legambiente
- Dettagli
- Scritto da Ivana Marrone su Collettiva
La carovana della Cgil arriva fino a Sobrance, tra Slovacchia e Ucraina, per consegnare le 17 tonnellate di aiuti alimentari alle popolazioni sfollate e costrette a fuggire dalle bombe di Putin
Riso, biscotti, latte a lunga conservazione, alimenti per neonati, succhi di frutta, prodotti per l'igiene personale. Generi di prima necessità per chi, una volta scappato dalle bombe, deve sopravvivere nella nuova “vita” da profugo. È il racconto della delegazione capitanata dalla Cgil nazionale insieme alla Flai Cgil, Cgil Emilia-Romagna, Cgil Lombardia, Spi Cgil Lombardia, Cgil Milano, Nexus Emilia Romagna che ha attraversato il cuore dell'Europa ed è arrivata a Sobrance, al confine con l'Ucraina, per consegnare gli aiuti alimentari.
- Dettagli
- Scritto da Legambiente, Anab
-
Il possibile massimo utilizzo del cartongesso dismesso nello stabilimento di Borgo Rivola, permetterebbe di utilizzare molto meno materiale vergine e quindi di scavare meno, attivando una filiera di raccolta del materiale recuperato, che oggi non viene utilizzato.
-
La progettazione a Borgo Rivola, da parte della Saint-Gobain, di una attività industriale di prodotti alternativi con l’impiego di argille e fibre naturali, come canapa ecc. che potrebbero essere coltivati in zona, verso la costruzione un distretto di materiali edili innovativi.
-
in aggiunta, anche rispetto alla candidatura Unesco per la Vena del Gesso, assieme all'Ente Parco, vanno realizzate altre iniziative economiche, culturali, turistiche di tutela del paesaggio; ipotesi annunciata anche dell'azienda, con un programma di ripristino innovativo e sostenibile, ma che non è ancora stato presentato.
- Dettagli
- Scritto da Massimo Franchi su il manifesto
SCAFFALE. «Il lavoro operaio digitalizzato», a cura di Garibaldo e Rinaldini e «Sfruttamento 4.0» di Gaddi
La rivoluzione tecnologica dentro le fabbriche della rossa Bologna (e provincia). Industria 4.0 declinata all’emiliana grazie alla mediazione decisiva del sindacato e dei suoi delegati in fabbrica. Due libri per un’unica «inchiesta operaia» del terzo millennio. Il lavoro operaio digitalizzato, inchiesta nell’industria metalmeccanica bolognese a cura di Francesco Garibaldo e Matteo Rinaldini (Il Mulino, pp. 216, euro 20) e Sfruttamento 4.0, nuove tecnologie e lavoro (Punto Rosso, pp. 240, euro 18, introduzione di Sergio Bologna ) di Matteo Gaddi – che ha collaborato anche al primo – sono veri e propri lavori sul campo, figli di visite alle aziende e interviste ai lavoratori.
Per mettere in fila le cose di un processo complesso un punto fermo iniziale c’è: i nuovi tempi di lavoro sono imposti dalle aziende e mai contrattati. I nuovi sistemi di produzione in linea hanno come scopo principale la riduzione dei tempi morti e la produzione just in time. Lavoratori e sindacati sono rimasti inizialmente spiazzati da questa rivoluzione che sulla carta metteva a repentaglio tanti posti di lavoro sostituiti dai robot e dell’automazione dei processi. Ma proprio il retroterra culturale di una terra in cui dagli anni ’50 il sindacato è stata parte attiva e innovativa nel cambiamento del modello di produzione è fondamentale per comprendere lo sviluppo dialettico dell’applicazione di industria 4.0 nelle fabbriche ancora dominate dalla partecipazione operaia.
LA FIOM DI BOLOGNA è centrale in questo processo. Un sindacato dalle radici antiche e conflittuali e una pratica sempre innovativa e analitica che punta costantemente a migliorare le condizioni degli operai. Se certamente Il lavoro operaio digitalizzato è un testo più analitico, Sfruttamento 4.0 lo compendia dal punto di vista della denuncia di un modello «non di mera introduzione di nuove tecnologie ma di business strettamente determinati dalle condizioni di mercato» che senza la mediazione del sindacato di fabbrica rischia di slittare verso «ritmi di lavoro insostenibili e controllo delle prestazioni dei lavoratori in competizione con eventuali fornitori esterni».
DUNQUE A «INDUSTRIA 4.0» – termine coniato in Germania nel 2013 con intento positivo per aumentare la competitività del sistema industriale e importato in Italia in gran parte per sdoganare incentivi alle imprese per comprare macchinari tecnologici (il famoso piano Calenda) – va tolta la patina retorica della «grande conquista». Si tratta di «una sfida» in primis per il sindacato. L’espressione «contrattare l’algoritmo» è troppo generica e illusoria e difatti mai citata nel libro a cura di Garibaldo e Rinaldini. La Fiom in stretto contatto con i suoi delegati – «il collante», lo definisce un operaio intervistato, tra manager e lavoratori – ha costruito e adottato una strategia fatta di conquiste su campi distinti dai ritmi di lavoro ma altrettanto importanti e innovative partendo dall’assunto che «le nuove tecnologie non devono ridurre i livelli occupazionali».
E dunque nelle grandi fabbriche bolognesi delle multinazionali – Ducati e Lamborghini di proprietà dei tedeschi di Audi, la autoctona Gd leader mondiale del packaging, i carrelli elevatori della Cesab di proprietà dei giapponesi di Toyota – la Fiom è riuscita a tutelare e spesso migliorare le condizioni di lavoro – il cosiddetto «tempo esterno» in primis con aumento dei congedi e ore di formazione, orari di entrate e uscita flessibili, ergonomia delle postazioni – senza dimenticare gli aumenti salariali e limitando «l’intrusione della sorveglianza algoritmica» evitando che il controllo delle prestazioni possa essere usato contro i lavoratori.
MA IL RISULTATO più peculiare dal punto di vista sindacale è certamente quello di aver evitato di scadere negli accordi aziendali-corporativisti ma costruendo una piattaforma comune che non dimentica i lavoratori degli appalti e delle forniture, cercando di contrattare uguali condizioni anche per loro in nome dell’universalismo che caratterizza il sindacato del bolognese Claudio Sabattini.
- Striscia di sangue infinita, la strage dei bambini senza volto - di Eliana Riva
- Tossine letali e lacrime di coccodrillo - di Micaela Bongi
- «Prima noi», Trump dichiara la guerra mondiale dei dazi - di Marina Catucci
- Difesa europea, Europarlamento approva Relazione: Pd dice sì, M5S attacca adn Kronos
- Il protezionismo che accelera la crisi dell’impero americano - di Emiliano Brancaccio
- 5 aprile, Avs aderisce Conte chiama Schlein «Confido che ci sia» - di Giuliano Santoro
- «Pronti a rispondere» ma l’Unione europea già si guarda in tasca - di Andrea Valdambrini STRASBURGO
- Netanyhau a Budapest, la chiamata è per l’Europa- di Luca Baccelli
- Schlein chiude a Calenda: «Noi al governo solo col voto» - di Andrea Carugati
- «ll no al riarmo oltre i confini di parte, la piazza del 5 aprile è aperta» - di Giuliano Santoro
- Orbán calpesta l’Aja: Netanyahu ospite d’onore a Budapest - di Lorenzo Berardi
- Lunedì Rosso del 31 marzo 2025
- Economia - Meloni ha un problema: si chiama von der Leyen - di Roberto Ciccarelli
- Al cuore del progetto autoritario - di Francesco Strazzari
- Landini: «Per fermare la guerra servono diritti e democrazia» - di Giuliano Santoro