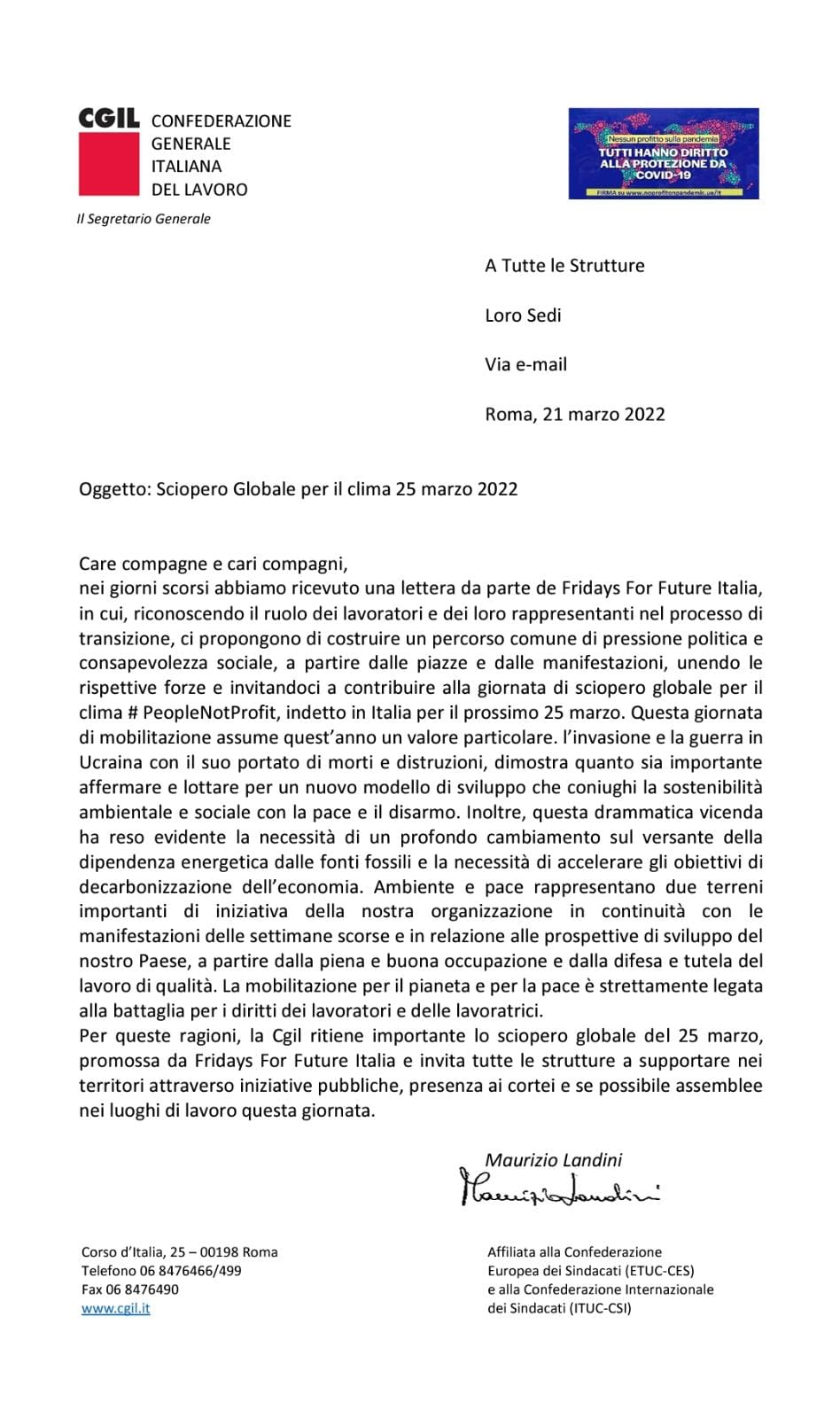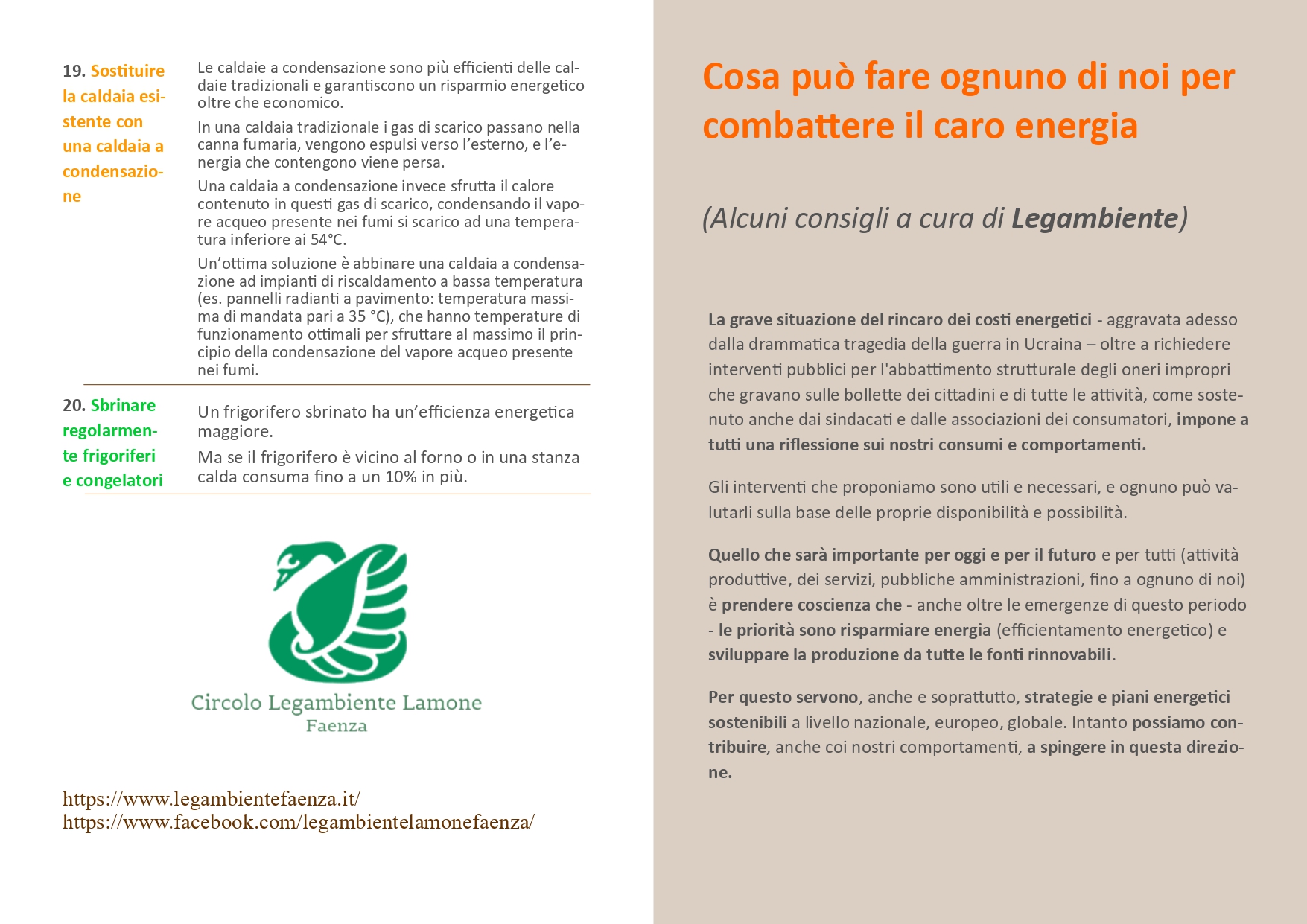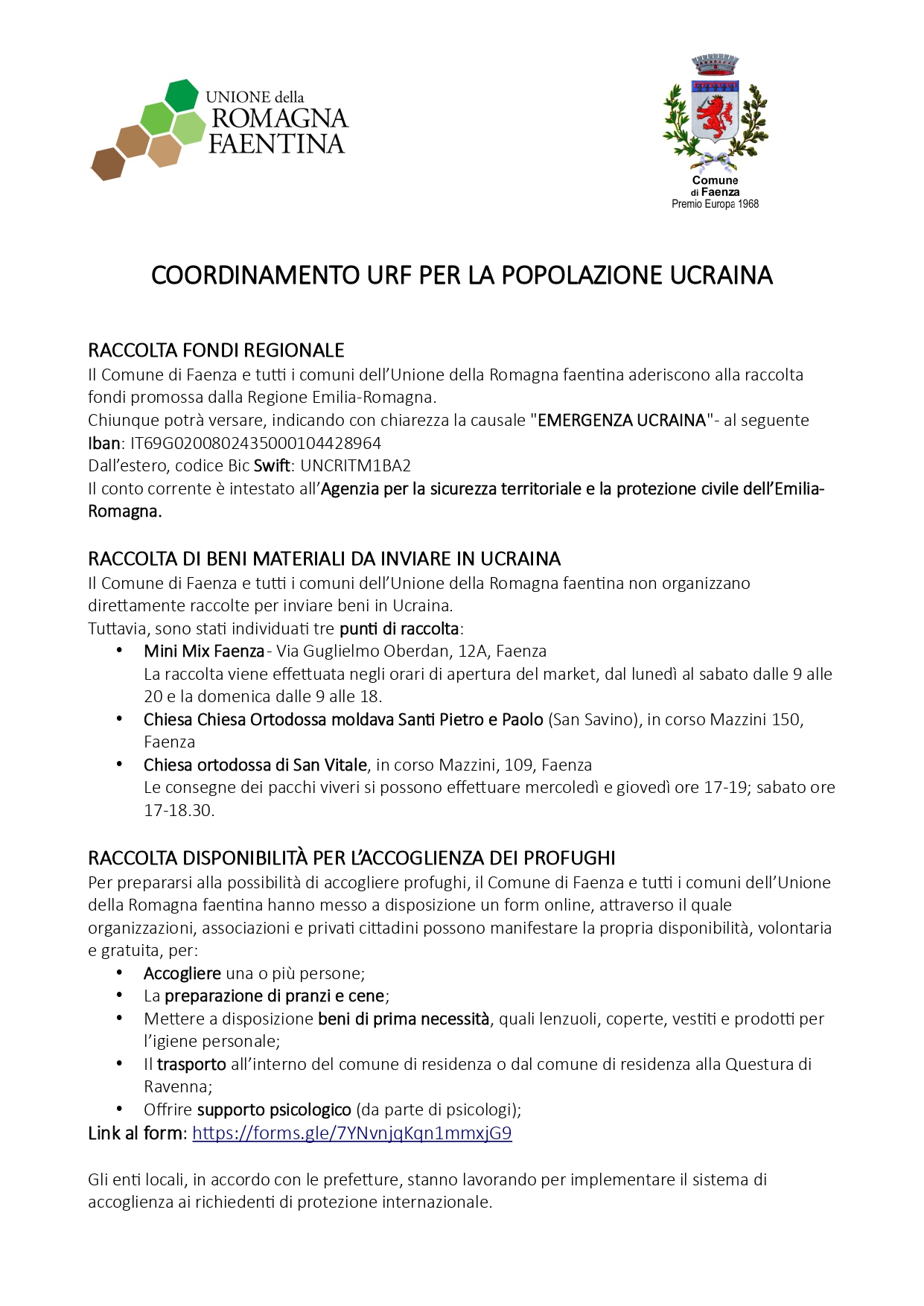- 1 . 04 - stasera I referendum in TV
- 28 . 3 - 3 . 4 - Programma del Cinema europa
- 2 . 04 - ore 20,30 - Museo Malmerendi - Alberi in città , conoscerli e prendersene cura
- 3 . 04 - ore 18 - Faventia Sales - Presentazione della ricerca- progetto MEGLIO RIUSARE CHE BUTTARE
- 4 . 04 - ore 17,30 - Lectio magistralis del Prof. Giorgio Parisi: "Energie rinnovabili per l'autonomia energetica dell'Italia, Il nucleare che c'entra?
- 4 . 04 - ore 21 - Rimini - Incontro con Luisa Morgantini - Presidente AssoPalestina
- 5 . 04 - ore 17,30 Bottega Bertaccini - Ferdinando Pelliciardi presenta il libro "Pavlon matt"
- 5 . 04 - Roma - manifestazione Movimento 5 stelle: No al riarmo dell'Unione Europea
- 8 . 04 - ore 20,30 Cinema Europa proiezione di Cortometraggi "100x100 Gaza non finirò di amarti mai"
- 11 . 04 - 18,30 - 20,30 - Assemblea/aperitivo del Circolo Legambiente Lamone
- 12 . 04 - Il 12 aprile a Ravenna «per il clima, fuori dal fossile» - di Luca Martinelli
- 12 . 04 - ore 17 - Faenza Museo del Risorgimento - Corbari - Curbéra l'umo, il partigiano, il mitora
- 3 - 5 -8 - 11- 12 - 14 . 04 - Ravenna - un mese di iniziative per USCIRE DALLA CAMERA A GAS
- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente
- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"
- Diritto di voto elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie 8 e 9 giugno 2025, Scarica la domanda editabile di ammissione al voto
- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !
- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia
- Dettagli
- Scritto da Legambiente Emilia Romagna
A Bologna, presso la “Terza torre” della Regione Emilia-Romagna, ieri si è svolto il terzo appuntamento del ciclo di seminari del progetto CAPSUS - The Common Agricultural Policy toward SUStainability , progetto finanziato dal programma IMCAP dell’Unione europea. Claim dell’evento: “Dalle strategie Farm to Fork e Biodiversità 2030 alla PAC 2023/2027 per una filiera agroalimentare più sostenibile”. In occasione dell’iniziativa patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, sono stati presentati il “Dossier pesticidi” a cura della sede regionale di Legambiente e il volume “Agroecologia circolare, dal campo alla tavola – Coltivare biodiversità e innovazione” a cura di Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente, e Giorgio Zampetti, direttore generale dell’associazione , che descrive in forma divulgativa, supportata da solide basi scientifiche, tutti gli aspetti e le diverse articolazioni di una vera e propria roadmap verso l’agroecologia. Un percorso che si snoda attraverso vari aspetti: da quelli ambientali e agronomici, a quelli legati alle politiche europee e nazionali, fino agli aspetti sociali ed economici; non mancano, poi, riferimenti al rapporto con gli stili di vita, alla dieta mediterranea e alla nostra salute, ma anche con l’innovazione tecnologica e la ricerca, l’economia circolare, la cura della biodiversità e i legami con i territori. Di sicuro interesse, inoltre, il capitolo dedicato al fenomeno delle agromafie. Tra i temi affrontati nel seminario, l’attuale crisi alimentare legata al conflitto in Ucraina che, nell’opinione dell’associazione del cigno verde, non deve rappresentare una battuta di arresto per la transizione in agricoltura ma, al contrario, una spinta propulsiva a fare ancora di più e nel minor tempo possibile.
Da Legambiente un monito inequivocabile: nonostante la complessa congiuntura geopolitica che sta mettendo a durissima prova tutto il settore agricolo, occorre andare avanti sulla strada della sostenibilità per rendere i sistemi agroalimentari meno vulnerabili e gettare subito le basi di una nuova agricoltura capace di affrontare la transizione ecologica.
“Il conflitto in Ucraina - ha dichiarato il direttore generale di Legambiente, Giorgio Zampetti - ha ben evidenziato la vulnerabilità dell’Unione europea sia sotto il profilo delle importazioni di materie prime che per quanto concerne la partita energetica. Tale fragilità dimostra quanto sia urgente e irrimandabile una profonda trasformazione dell’intera filiera agroalimentare, tenendo conto in ogni azione della necessità di un supporto concreto e immediato agli agricoltori. Promuovere modelli produttivi e di consumo più resilienti e soprattutto più sostenibili è l’unica alternativa che abbiamo a disposizione. Pensare di risolvere l’attuale crisi puntando sugli stessi sistemi produttivi e modelli di consumo che ci hanno condotto in questa situazione sarebbe profondamente sbagliato. Di sicuro - ha concluso Zampetti -, non è scommettendo su una produzione nemica dell’ambiente che si risolveranno i problemi del presente, come non lo si farà continuando a investire nelle risorse fossili in ambito energetico.”
“La sfida di oggi - ha dichiarato Angelo Gentili - è quella di riuscire a liberare la transizione ecologica da un dibattito eccessivamente polarizzato che rischia di inceppare la corsa verso il futuro. Su una cosa vogliamo essere chiari: il comparto agricolo sta facendo fronte a una crisi estremamente e drammaticamente complessa e di questo dobbiamo esserne tutti consapevoli. Il conflitto in Ucraina, la crisi energetica e quella legata all'approvvigionamento delle materie prime non devono rappresentare una battuta di arresto per l’agroecologia. Al contrario, devono essere interpretate come un motivo in più per lavorare in questa direzione. Ciò alla luce anche del fatto che parte della responsabilità delle crisi in corso è proprio dovuta all’incapacità dell’Europa di rendersi autonoma dai mercati esteri anche in ambito agricolo. Per questo, la battaglia climatica e quella per la sostenibilità economica delle misure da mettere in campo devono andare di pari passo attraverso un rapido ed evidente intervento del Governo centrale. Del resto, attendere l’operatività della nuova PAC è impensabile, considerando il repentino e notevole aumento dei prezzi delle materie prime. In occasione del seminario di ieri - ha aggiunto Gentili - lo abbiamo ribadito con forza: perdere di vista le grandi urgenze ambientali che abbiamo davanti sarebbe disastroso. All’ordine del giorno delle agende dei decisori politici deve continuare ad esserci la sostenibilità ambientale in agricoltura, a partire dall’attuazione delle strategie “Farm to fork” e “Biodiversità 2030”, senza correggere al ribasso le misure ambientali previste della nuova PAC post 2022 e lavorando incessantemente per raggiungere tutti gli obiettivi posti tra cui la significativa riduzione degli input chimici ed energetici del settore.”
Nell’ambito del seminario anche un focus territoriale, a partire dai dati della quarta edizione del “Dossier pesticidi” (scaricabile a a questo link) realizzato da Legambiente Emilia-Romagna. Tra i dati emersi, quelli relativi alle stazioni che negli anni 2018, 2019 e 2020 hanno superato i parametri degli standard di qualità ambientale (SQA) di 1 µg/l per la media della sommatoria di più sostanze per singole stazioni relative alle acque superficiali. Attenzione particolare anche alle più recenti rilevazioni di glifosate e del suo metabolita AMPA, che, a partire da metà del 2018, sono state rinvenute anche in Emilia-Romagna.
“In occasione del seminario svoltosi nella giornata mondiale dell'acqua che si celebra proprio il 22 marzo - dichiara Davide Ferraresi, presidente Legambiente Emilia-Romagna -, obiettivo comune è stato anche quello di accendere i riflettori sulla necessità di vigilare sull’applicazione dei disciplinari di produzione integrata e delle misure per ridurre la chimica in agricoltura, affinché abbiano effetti concreti sulla dispersione dei fitofarmaci nelle acque, in linea con quanto previsto dalle strategie europee. Dai dati elaborati per il “Dossier pesticidi” negli anni presi in considerazione risulta evidente come la presenza in particolare di AMPA, metabolita del noto e abusato erbicida glifosate, abbia inciso in maniera determinante nello sforamento degli SQA da parte di decine di stazioni di monitoraggio. Rispetto alle sole 4 stazioni “fuori legge” del 2014, nel 2020 in Emilia-Romagna sono state registrate ben 31 stazioni che superano abbondantemente il limite di 1 µg/l, con un’importante impennata dal 2018, anno in cui sono cominciati i rilevamenti di AMPA e glifosate sul territorio regionale. La regione Emilia-Romagna già dal 2016 con le linee di indirizzo ministeriali e dal 2018 con ulteriori restrizioni, ha limitato l’impiego di glifosate sia all’interno delle aree agricole (con limitazioni sulle coltivazioni e divieto in aree improduttive) che di quelle extra agricole. Nonostante queste disposizioni, la presenza di AMPA nei campionamenti, insieme alle numerose segnalazioni di diserbi indiscriminati sul territorio, raccontano un utilizzo spropositato dell’erbicida. Alla luce di ciò, risulta palese la necessità di misure di presidio puntuali sul territorio, almeno nelle stagioni di massimi trattamenti fitosanitari, per scoraggiare i possibili trasgressori. La fotografia restituita dal dossier dimostra quanto ancora ci sia da fare anche in Emilia-Romagna per rendere reale un’agricoltura sana per l’ambiente e per la nostra salute. La nostra è la quarta Regione in Italia per superficie coltivata a biologico. L’amministrazione regionale ha fissato l’obiettivo di arrivare, entro il 2030, a coprire più del 45% della SAU con pratiche a basso input, di cui oltre il 25% a biologico, in linea con gli obiettivi Ue. Una posizione sicuramente virtuosa con obiettivi ambiziosi, su cui però ad oggi servono, come in passato, nuove spinte, anche e soprattutto nonostante le enormi difficoltà del momento.”
All’incontro hanno partecipato, tra gli altri: Angelo Gentili , responsabile agricoltura di Legambiente; Giorgio Baracani , vicepresidente CONAPI; Cristiano Fini , presidente CIA Emilia Romagna; Nicola Bertinelli , presidente Coldiretti Emilia Romagna; Marcello Bonvicini , presidente Confagricoltura Emilia Romagna; Lucio Cavazzoni , presidente comitato promotore distretto biologico dell’Appennino bolognese; Simone Andrei , presidente biodistretto Alte valli; Paola Fagioli , direttrice Legambiente Emilia Romagna; Lucia Culicchi , ufficio Legambiente agricoltura; Giorgio Zampetti , direttore generale Legambiente. A moderare l’incontro, Davide Ferraresi, presidente Legambiente Emilia-Romagna.
Scarica il Dossier Pesticidi Emilia-Romagna
- Dettagli
- Scritto da Maurizio Landini
- Dettagli
- Scritto da Legambiente, Greenpeace Italia e Wwf Italia.
Presentate al governo dalle associazioni Legambiente, Greenpeace Italia e Wwf Italia. “Bisogna approvare con urgenza un decreto sblocca rinnovabili per sostituire le centrali a gas costruite dopo il blackout nazionale del 2003 e per ridurre i consumi di 36 miliardi di metri cubi entro il 2026”
La drammatica guerra in Ucraina e la preoccupazione per l’aumento del caro bollette impongono di accelerare la transizione energetica del nostro Paese. È l’unica soluzione per uscire dalla dipendenza dal gas, a partire da quello della Russia. Greenpeace Italia, Legambiente e Wwf Italia avanzano 10 proposte al governo Draghi per affrontare la dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento del gas. Si tratta di interventi normativi e autorizzativi da mettere in campo da qui ai prossimi mesi e che permetterebbero di ridurre i consumi di gas di 36 miliardi di metri cubi all’anno entro fine 2026, sviluppando l’eolico offshore e a terra, il fotovoltaico sui tetti, anche nei centri storici, e sulle aree compromesse (discariche, cave, etc), il moderno agrivoltaico che garantisce l’integrazione delle produzioni agricole con quella energetica, la produzione del biometano (sviluppata in un chiaro contesto di riduzione del numero complessivo di capi allevati e senza sottrazione di terreno alla produzione di cibo), gli accumuli, i pompaggi e l’ammodernamento delle reti.
Le richieste
Le tre associazioni chiedono di autorizzare, entro marzo 2023, nuovi impianti a fonti rinnovabili per 90 GW di nuova potenza installata, pari alla metà dei 180 GW in attesa di autorizzazione, da realizzare entro fine 2026; aggiornare entro giugno 2022 il PNIEC, valutando l’obiettivo di produzione del 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2035; fissare subito un tetto ai profitti delle aziende che estraggono e trasportano gas fossile o petrolio; attivare entro giugno 2022 il dibattito pubblico sugli impianti a fonti rinnovabili al di sopra dei 10 MW di potenza installata; sviluppare la produzione di biometano da FORSU, scarti agricoli, reflui zootecnici e fanghi di depurazione. E poi di escludere entro aprile 2022 l’autorizzazione paesaggistica per il fotovoltaico integrato sui tetti degli edifici non vincolati dei centri storici; rivedere entro dicembre 2022 i bonus edilizi, cancellando gli incentivi per la sostituzione delle caldaie a gas. Infine è importante anticipare al 2023 l’eliminazione dell’uso delle caldaie a gas nei nuovi edifici; istituire entro giugno 2022 un fondo di garanzia per la costituzione delle comunità energetiche; attivare entro maggio 2022 una strategia per efficienza e innovazione nei cicli produttivi e sulla mobilità sostenibile.
Le soluzioni anacronistiche del Governo
Negli ultimi mesi il tema energia è stato al centro del dibattito politico, anche grazie a un’incessante campagna mediatica sul tema dei rincari in bolletta e a forti dinamiche speculative, alimentate prima dall’aumento dei prezzi di acquisto del gas fossile sui mercati internazionali messi in campo dagli oligopoli delle fonti fossili, in seguito alla ripartenza dell’economia mondiale dopo le prime ondate del Covid-19, e poi dalle tensioni internazionali sfociate nella terribile guerra innescata dall’invasione russa in Ucraina.
“Il problema evidente del salasso per famiglie e aziende è urgente da affrontare, ma le soluzioni adottate o prospettate dal Governo – spiegano Greenpeace Italia, Legambiente e WWF Italia – sono anacronistiche e in controtendenza con l’urgente lotta alla crisi climatica: si va dall’aumento della produzione nazionale di gas fossile all’approvvigionamento di idrocarburi gassosi non provenienti dalla Russia, dalla possibile ripartenza di gruppi termoelettrici a carbone a quelli a olio combustibile, dal raddoppio di gasdotti operativi alla realizzazione di nuovi rigassificatori, fino ai nuovi finanziamenti alla ricerca del nucleare di quarta generazione. Il governo, per contenere gli aumenti in bolletta, ha pensato bene infine di tagliare gli extracosti relativi solo alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili, senza interessare minimamente quelli vertiginosi delle aziende delle fonti fossili o in modo strutturale tutti gli oneri di sistema in bolletta. Il blackout nazionale del 2003 portò al varo in fretta e furia dell’infausto decreto sblocca centrali del governo Berlusconi che fece realizzare le centrali termoelettriche a gas che allora sostituirono quelle a carbone e olio; oggi la guerra in Ucraina dovrebbe portare l’Esecutivo Draghi a varare subito un ben più necessario e fausto decreto sblocca rinnovabili per sostituire gli impianti a gas con 90 GW di nuovi impianti a fonti rinnovabili da autorizzare entro 12 mesi e da realizzare nei prossimi 5 anni”.
Serve ridurre i consumi di gas
Per le tre associazioni quelle prese fino ad oggi dall’esecutivo Draghi sono “decisioni che non entrano nel merito dell’unica soluzione efficace che ci può permettere di affrontare questo problema in modo strutturale e senza lasciare indietro nessuno: la riduzione dei consumi di gas. Un obiettivo che si può raggiungere intervenendo soprattutto sulle prime tre voci di consumo: domestico e terziario (33 miliardi di metri cubi nel 2021), la produzione di elettricità (26 miliardi di metri cubi) e l’industria (14 miliardi di metri cubi), su cui bisogna operare con un forte sviluppo delle fonti rinnovabili, concrete politiche di risparmio energetico ed efficienza energetica in edilizia, l’innovazione tecnologica nelle imprese”.
Pensare di riattivare gruppi termoelettrici a carbone o a olio combustibile è un’opzione irrilevante: se pure ripartissero 1.000 MW di potenza installata, aggiuntivi a quelli già in attività, con questi due combustibili fossili, ad esempio per 5mila ore all’anno, si potrebbero produrre 5 TWh all’anno che nei fatti permetterebbero di risparmiare solo 1 miliardo di m3 di gas fossile all’anno. Praticamente nulla al confronto del contributo strutturale e rispettoso degli obiettivi climatici e di lotta all’inquinamento atmosferico che garantirebbe lo sviluppo strutturale e convinto delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, del sistema di pompaggi e accumuli e della rete di trasmissione e distribuzione.
Le 10 proposte
1) Aggiornare entro giugno 2022 il PNIEC, valutando l’obiettivo della produzione del 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2035
2) Fissare entro aprile 2022 un tetto ai profitti delle aziende che estraggono e trasportano gas fossile o petrolio
3) Autorizzare, entro marzo 2023, nuovi impianti a fonti rinnovabili per 90 GW di nuova potenza installata, pari alla metà dei 180 GW in attesa di autorizzazione, da realizzare entro fine 2026. Sarà necessario, inoltre, accompagnare questo sviluppo con quelli degli accumuli e della rete che deve essere potenziata per poter ricevere e scambiare i flussi energetici
4) Attivare entro giugno 2022 il dibattito pubblico sugli impianti a fonti rinnovabili al di sopra dei 10 MW di potenza installata
5) Sviluppare la produzione di biometano da FORSU, scarti agricoli, fanghi di depurazione e reflui zootecnici, programmando parallelamente una riduzione dei capi allevati e senza entrare in competizione con l’uso di terreni per la produzione di cibo
6) Escludere entro aprile 2022 l’autorizzazione paesaggistica per il fotovoltaico integrato sui tetti degli edifici non vincolati dei centri storici
7) Rivedere entro dicembre 2022 i bonus edilizi, cancellando gli incentivi per la sostituzione delle caldaie a gas
8) Anticipare al 2023 l’eliminazione dell’uso delle caldaie a gas nei nuovi edifici
9) Istituire entro giugno 2022 un fondo di garanzia per la costituzione delle comunità energetiche
10) Attivare entro maggio 2022 una strategia per efficienza e innovazione nei cicli produttivi e sulla mobilità sostenibile
- Dettagli
- Scritto da Legambiente Circolo Lamone Faenza
La copertina di un semplice pieghevole che si può scaricare dal sito di Legambiente
- Dettagli
- Scritto da Da Collettiva.it
Il segretario generale della Cgil chiede un incontro immediato sul caro energia e sui beni di prima necessità: "La situazione è insostenibile e colpisce i lavoratori, servono soluzioni al più presto"
La Cgil chiede al governo una convocazione immediata per affrontare il caro sull'energia e sui beni di prima necessità. "Il governo ci deve convocare urgentemente. È necessario trovare subito soluzioni sul caro-energia e sui beni di prima necessità, e bisogna farlo coinvolgendo le organizzazioni sindacali”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo all’assemblea generale della Confederazione.
“Le lavoratrici e i lavoratori - prosegue - stanno pagando un prezzo troppo alto per una situazione che la guerra e la fase che stiamo vivendo ha ulteriormente aggravato”.
“Gli interventi sul fisco varati dal governo, come avevamo ampiamente previsto e denunciato, - aggiunge Landini - non hanno apportato alcun vantaggio per il mondo del lavoro. La situazione non è più sostenibile, quindi deve essere subito convocato un tavolo di confronto con il governo per trovare le soluzioni necessarie per affrontare la fase che stiamo attraversando”.
“Soluzioni che nell’immediato - conclude il segretario generale della Cgil - possono andare dall'azzeramento dell'Iva sui beni di consumo più diffusi, al taglio delle accise sui carburanti, fino alla tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche. Alla luce di quello che stiamo vivendo, inoltre, servono più che mai nuove politiche economico sociali e un intervento sul fisco a favore dei redditi più bassi”.
- Striscia di sangue infinita, la strage dei bambini senza volto - di Eliana Riva
- Tossine letali e lacrime di coccodrillo - di Micaela Bongi
- «Prima noi», Trump dichiara la guerra mondiale dei dazi - di Marina Catucci
- Difesa europea, Europarlamento approva Relazione: Pd dice sì, M5S attacca adn Kronos
- Il protezionismo che accelera la crisi dell’impero americano - di Emiliano Brancaccio
- 5 aprile, Avs aderisce Conte chiama Schlein «Confido che ci sia» - di Giuliano Santoro
- «Pronti a rispondere» ma l’Unione europea già si guarda in tasca - di Andrea Valdambrini STRASBURGO
- Netanyhau a Budapest, la chiamata è per l’Europa- di Luca Baccelli
- Schlein chiude a Calenda: «Noi al governo solo col voto» - di Andrea Carugati
- «ll no al riarmo oltre i confini di parte, la piazza del 5 aprile è aperta» - di Giuliano Santoro
- Orbán calpesta l’Aja: Netanyahu ospite d’onore a Budapest - di Lorenzo Berardi
- Lunedì Rosso del 31 marzo 2025
- Economia - Meloni ha un problema: si chiama von der Leyen - di Roberto Ciccarelli
- Al cuore del progetto autoritario - di Francesco Strazzari
- Landini: «Per fermare la guerra servono diritti e democrazia» - di Giuliano Santoro