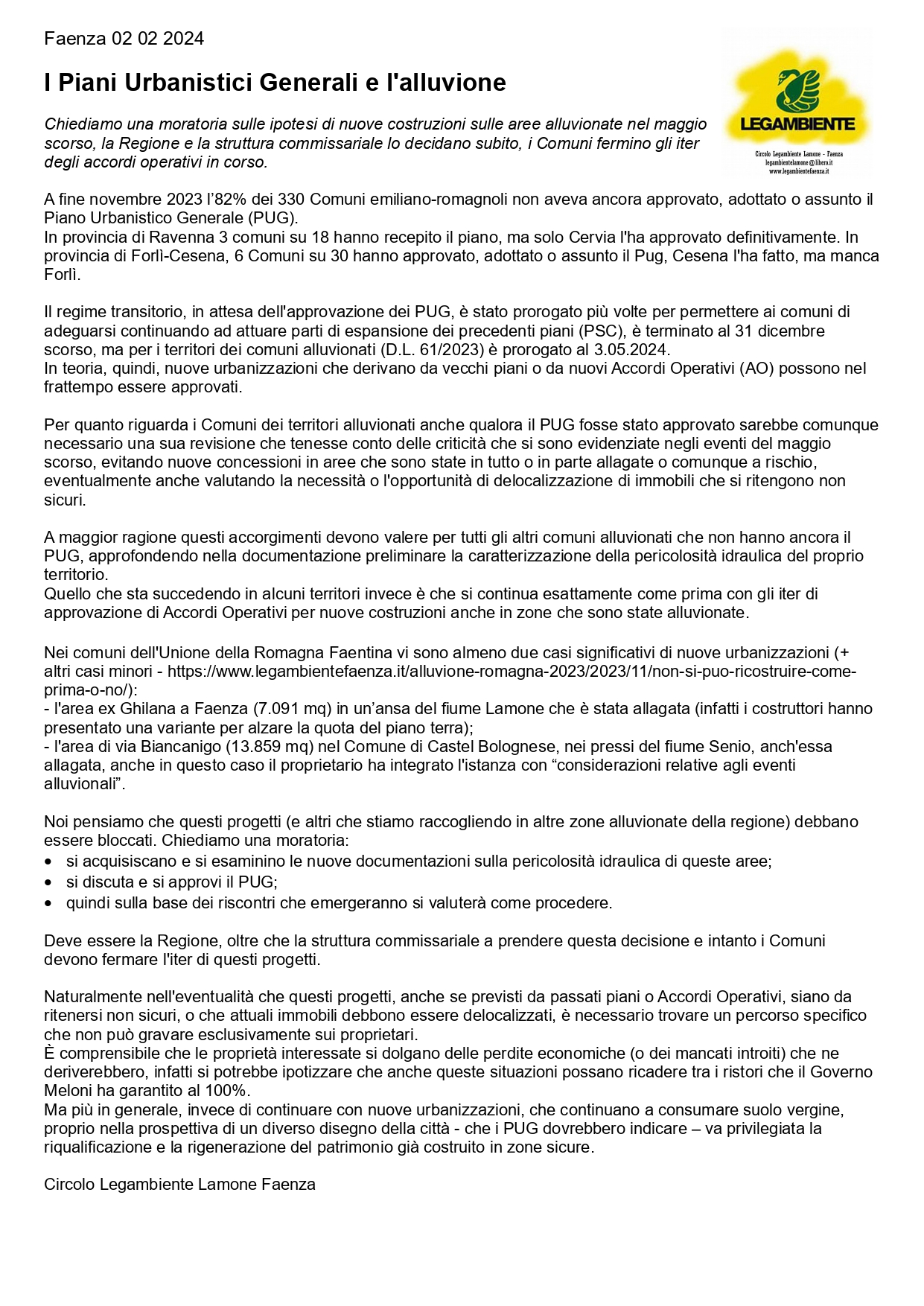La giornata, che sarà conclusa dal segretario generale Maurizio Landini, si svolgerà durante quattro sessioni, dalle ore 9 alle ore 16.45, che vedranno un confronto di numerosi e numerose esponenti del mondo accademico e sindacale che discuteranno del concetto di autonomia in un’ottica storico-sindacale.
Un’altra idea di autonomia - di Riccardo Ciccarelli
Autonomia come autogoverno e autodeterminazione delle persone, della classe, dei popoli. Autonomia operaia e dei consigli di fabbrica. Autonomia come democrazia diretta, sociale e politica. Queste, e altre declinazioni, del concetto – quello di «autonomia», appunto – sono state fatte nella lunga e travagliata storia della sinistra sindacale, comunista, socialista e liberale.
QUESTA STORIA si è sviluppata sempre nel fuoco delle lotte in Italia. Ha dato esiti stupefacenti molti fallimenti, riprese insperate. Fu rielaborata dall’Ordine Nuovo con Antonio Gramsci nel primo «biennio rosso» (1919-1920). Il grande politico e filosofo, fondatore del Pci, allora parlava di una delle istituzioni dell’autonomia: i «consigli operai». Erano «cellule prime» della democrazia rivoluzionaria. L’idea dell’«autonomia» tornò trasformata nel secondo «biennio rosso»: tra il 1968 e l’«autunno caldo» del 1969. Nacquero le organizzazioni autonome: il Consiglio Unitario di base (Cub) alla Pirelli di Milano. Altri consigli di fabbrica si erano strutturati prima.
UNA STORIA POTENTE. Ha attraversato prospettive leniniste, luxemburghiane, proudhoniane, gramsciane, socialiste e comuniste, liberalismi originali opposti a quelli classisti ed economicisti. C’è stata l’epica, la tragedia e il martirio. Quello di Piero Gobetti ucciso dai fascisti. Ci sono le traiettorie di socialisti come Vittorio Foa, oppure quelle di fondatori dell’operaismo: un gigante come Raniero Panzieri, per esempio. La riflessione sull’autonomia si ritrova, in altre posizioni, quelle di un segretario della Fiom e della Cgil, oltre che pensatore di prim’ordine: Bruno Trentin.
CI SONO STORIE di formidabili dibattiti pratici e teorici che hanno coinvolto le riviste più belle, i convegni più combattuti, gli intellettuali, gli operai, i militanti culturali e di base. Ci fu il dibattito sulle «sette tesi sul controllo operaio» del 1958 di Raniero Panzieri e Lucio Libertini sulla rivista del Psi «Mondo operaio». Molti ricordano e praticano l’operaismo dei «Quaderni Rossi».Su un altro versante possiamo trovare, per esempio, la storia della «nuova sinistra», quella de Il Manifesto. E ancora i movimenti rivoluzionari degli anni Settanta. In tutta evidenza, non stiamo parlando di una prospettiva unica, ma irriducibilmente plurale, spesso conflittuale, comunque problematica. Com’è la storia delle sinistre. Mille fili che però oggi potrebbero essere intrecciati in una genealogia eretica. Per creare nuove idee e cortocircuiti nel presente.
QUESTA È STATA l’intuizione che ha ispirato un bel convegno organizzato ieri all’università Roma Tre dalla Fondazione Di Vittorio (Cgil). I densissimi interventi, senza una pausa, possono essere ora rivisti sul sito Collettiva.it. In tale contesto è stata avanzata un’ipotesi di lotta culturale, dunque politica.
OGGI, È STATO DETTO, il concetto di «autonomia» è stato sequestrato dalle destre leghiste e postfasciste che compongono il governo Meloni. Quest’ultimo si regge su uno scambio osceno che rompe l’unità nazionale e rafforza l’autoritarismo dilagante. I leghisti Salvini e Calderoli vogliono imporre l’«autonomia differenziata», una «secessione» delle regioni «ricche» (Veneto e Lombardia, per cominciare) che aspirano a costituirsi in micro-staterelli. Meloni e i suoi «Fratelli d’Italia» vogliono il «premierato» che metterà in discussione sia il parlamento che le funzioni dello stesso presidente della Repubblica.
«LA STORIA DELL’AUTONOMIA come autogoverno e come pratica democratica non ha nulla a che vedere con l’autonomia differenziata di Calderoli ed è l’antidoto allo scambio osceno con il presidenzialismo di Meloni -ha detto Francesco Sinopoli, presidente della Fondazione Di Vittorio – Si tratta di un doppio autoritarismo. Per contrastare questa deriva possiamo ispirarci a queste tradizioni. Bisogna tornare a lavorare dal basso, cambiare profondamente il sistema sociale. La sinistra di governo ha gravissime responsabilità. Senza la riattivazione della partecipazione democratica nella società e nel lavoro non sarà possibile rispondere alla crisi della partecipazione sulla quale cresce anche la regressione in atto».
«IL DIBATTITO SUI CONSIGLI di fabbrica oggi è prezioso – ha detto Luciana Castellina, co-fondatrice de Il Manifesto – Anche oggi è possibile immaginare forme di democrazie diretta non solo nei luoghi di lavoro ma nella società. Da qui possiamo ripartire nel momento in cui prevale la frammentazione e l’astensionismo. Possiamo reimpadronirci della gestione di pezzi della società costruendo poteri sul territorio. la gestione diretta dei beni comuni serve anche a cambiare la cultura diffusa attraverso le pratiche della democrazia diretta. Oggi non c’è solo la fabbrica, che è decentrata al suo interno da appalti e subappalti. Il nostro problema è creare poteri collettivi, decentrati e diffusi, anche fuori da essa, cioè nuove istituzioni nella società».
«CON LA PROPOSTA del “sindacato dei diritti” Bruno Trentin ha indicato come il sindacato deve aprirsi alla partecipazione dei cittadini e unirla a quella sui luoghi di lavoro. Questa idea pone la necessità di una maggiore radicalità della nostra azione – ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini – Il governo ha un progetto organico, corporativo, autoritario. Meloni ha chiesto il referendum sulla riforma costituzionale per affermare la propria leadership. Noi dobbiamo usare il referendum per obiettivi opposti e affermare la democrazia in nome della Costituzione. Dobbiamo portarci all’altezza dello scontro o rischiamo che il conflitto prenda un’altra strada»