Acciaio fuso. Per salvare lavoro e salute, non si può fare una politica industriale a pezzetti, servirebbero manager pubblici, come, a suo tempo, in Italia non sono mancati.
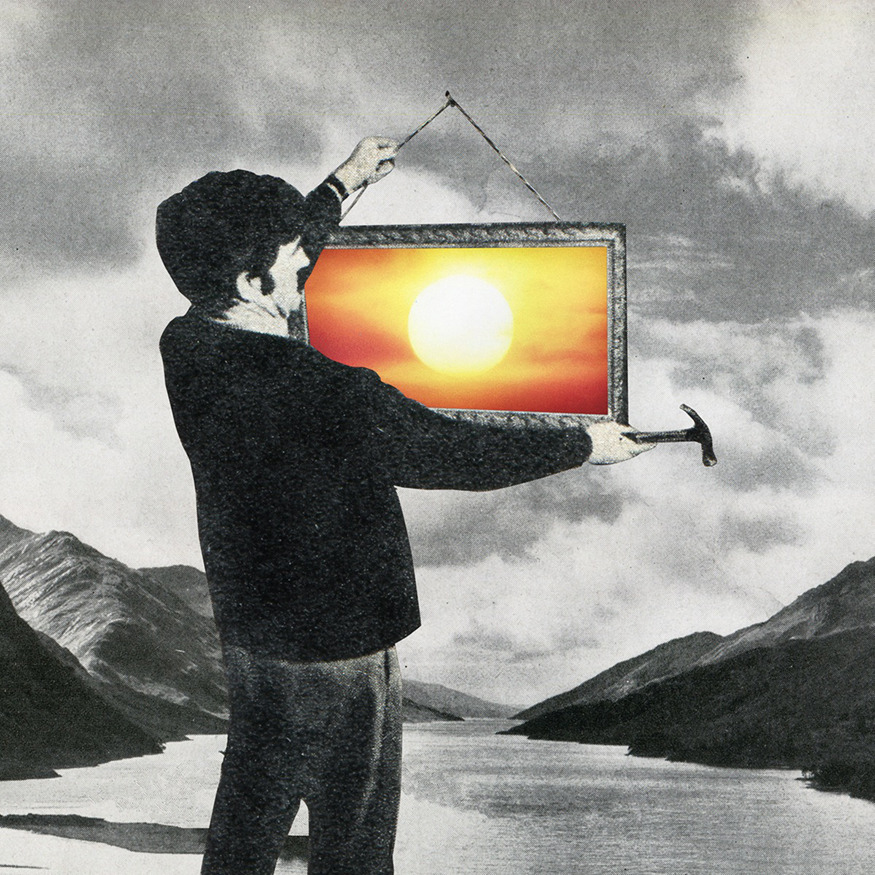
La drammatica vicenda dell’Ilva richiama un groviglio di questioni e di responsabilità da dipanare se si vuole una soluzione alla questione ambientale e sociale che essa ha suscitato. Non sono d’aiuto, anzi d’impaccio, le polemiche tra incompetenti e irresponsabili.
La gravità della situazione impone di andare alle radici del problema. Quando si confrontano e si scontrano due diritti fondamentali esplicitamente tutelati della Costituzione, due beni comuni potremmo anche dire, come il lavoro e la salute degli individui e della comunità, e tale scontro non trova soluzione, se non distruttiva per uno di questi diritti o per entrambi, nel perimetro determinato dalle scelte dell’industria privata votata al profitto, c’è un’unica soluzione possibile: la nazionalizzazione dell’impresa.
Tanto più che in questo caso parliamo di un settore da considerarsi strategico per un paese che non vuole rinunciare ad una sua dimensione industriale e di un’azienda che, pur avendo un’estensione nazionale, è principalmente collocata in un Mezzogiorno sempre più alla deriva economicamente e socialmente come lo stesso ultimo rapporto Svimez ha inequivocabilmente dimostrato.
Conosco l’obiezione: la pubblicizzazione di un’impresa o anche di un intero settore di per sé non garantisce della qualità dei piani e delle scelte industriali praticate, né della buona cura del territorio circostante.
Nessuno dimentica la polemica contro le “cattedrali nel deserto”, locuzione profetica coniata da Luigi Sturzo nel 1958, agli inizi del “miracolo economico” italiano, con particolare riferimento alla Sicilia e che diventò un cavallo di battaglia del Pci nella sua polemica contro la politica delle Partecipazioni statali. Né hanno fatto meno disastri le “cattedrali nelle città”, come il quarto centro siderurgico, l’allora Italsider di Taranto, sorto a metà degli anni sessanta. “Un progetto barbarico di industrializzazione” lo definì Antonio Cederna.
Non bastano dunque l’intervento e la proprietà pubblica. Ci vuole una visione strategica complessiva della politica economica, industriale e ambientale per l’intero paese, tanto più quando la sua economia è fortemente integrata a livello internazionale ed europeo in particolare.
Ma l’esperienza fatta dalle sciagurate privatizzazioni messe in atto da quarant’anni a questa parte mostra che si poteva fare di peggio e lo si è fatto. Inchiodare Ancelor alle sue specifiche responsabilità è giusto nell’immediato, se non altro per farle pagare il prezzo più alto. Si afferma che la cancellazione dello scudo penale come lo stesso intervento della Magistratura, che dopo la morte di un lavoratore ha imposto il blocco dell’altoforno Afo2 fino ad adeguamento tecnologico, siano una pura foglia di fico. Se si è convinti di questo non ha molta potenzialità deterrente ripristinare lo scudo. Il Re è già nudo. E poi come?
Si dice che le colpe dei precedenti inquinatori del territorio e avvelenatori della salute non possono pesare sulla nuova gestione. Ma se questo dopo non differisce molto dal prima, se il piano di risanamento batte la fiacca o non comincia, non è possibile preassicurare l’impunità. Pare che il governo pensi a un nuovo decreto.
Intanto ministri dichiarano rassicuranti che chi inquina deve pagare. Ma cosa, i funerali delle vittime di cancro del quartiere Tamburi e oltre?
Le preoccupazioni costituzionali espresse da Flick, già Presidente della Consulta, non sono affatto peregrine. Si può – forse, ma con tutte le cautele e i distinguo necessari – fare un’eccezione quando è in corso una realizzazione guidata e attuata dallo Stato, ma non estenderla a imprenditori privati il cui fine dichiarato è la profittabilità dei loro investimenti. Come in questo caso, visto che la richiesta di considerare esuberi strutturali 5mila lavoratori, cioè la metà degli occupati nello stabilimento tarantino, e di ridurre il volume della produzione deriverebbe dalle difficoltà dell’acciaio nel mercato internazionale manifestatesi l’anno scorso.
Ma proprio questo ci dice che la proprietà deve passare di mano. Non si può pensare di inseguire all’infinito, con commissariamenti a tempo, nuovi partner-padroni internazionali. Proprio perché la situazione economica mondiale si presenta come stagnante con il rischio di nuove pesanti recessioni, diventa suicida mettersi nelle volubili e capricciose mani del mercato internazionale, sia quello finanziario che quello delle materie basiche per l’industria.
Si dice che la Cassa Depositi e Prestiti non dev’essere la madonna pellegrina. Ma neppure il convitato di pietra. Se non interviene in un caso del genere non si capisce a cosa serva.
Naturalmente non si può fare una politica industriale a pezzetti, passando da un’emergenza all’altra, tappando buchi qua e là. E servirebbero dei manager pubblici, o meglio dei civil servant all’altezza, come a suo tempo in Italia non sono mancati. Tanto più per attuare una complessiva conversione ecologica dell’economia, come sarebbe necessario data l’incidenza delle attuali produzioni sul riscaldamento climatico.
Serve una visione di insieme, non ristretta ai confini nazionali, entro cui stabilire una programmazione degli interventi pubblici per guidare un simile processo.
Altrimenti si ripropone l’orribile, quanto disastrosa in ogni caso, scelta tra salvare la fabbrica e difendere la salute di chi ci lavora e di chi abita nel territorio circostante.
Inutile dire che nella legge di bilancio di tale prospettiva non v’è traccia, quando invece la sorte della siderurgia ne richiederebbe la sostanziale revisione. Su questo varrebbe sì la pena di uno scontro con la Ue, per la vita e il lavoro, non per qualche decimale in più.

